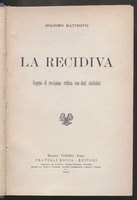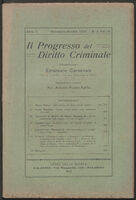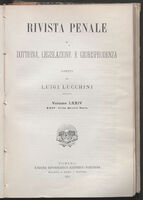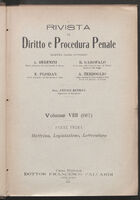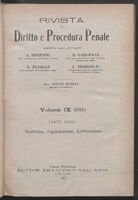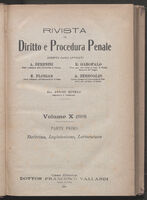Guida alla lettura - Il concetto di sentenza penale
Autore: Giacomo Matteotti Opera: Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare In Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Vol. LXXXVIII, pp. 206-225 e 353-380 Diretta da Luigi Lucchini Anno: 1918
Sintesi dell’opera
Il presente contributo di Giacomo Matteotti analizza in profondità la definizione giuridica di sentenza nell’ambito della procedura penale. L’autore critica l’art. 98 del codice di procedura penale del 1913, che avrebbe dovuto chiarire il concetto di sentenza ma che, a suo parere, risulta addirittura “superfluo, inesatto e non rispondente allo scopo”.
Matteotti sostiene che la legge non dovrebbe fornire definizioni dogmatiche, ma solo dettare norme applicative. Il compito del legislatore, infatti, consiste nello stabilire quando e come un provvedimento debba essere adottato, mentre la sistematizzazione e la definizione concettuale spettano alla scienza giuridica. L’art. 98, al contrario, cerca di stabilire una distinzione tra sentenze e ordinanze basata su criteri estrinseci, piuttosto che sulla sostanza della decisione. Il risultato è una proliferazione di dubbi e ambiguità, che la dottrina dominante dell’epoca non risolve, limitandosi alla “glossa che nulla chiarisce”.
L’autore esamina diversi casi in cui la denominazione di “sentenza” è attribuita in modo poco coerente, come nelle decisioni sulla ricusazione del giudice o nelle dichiarazioni di incompetenza. In particolare, Matteotti si sofferma sulle decisioni che dichiarano l’incompetenza del giudice e dispongono la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria. In questo ambito, il penalista di Fratta lamenta che il “codice attribuisce a codeste decisioni ora il nome di sentenza, ora di ordinanza, ora nessuno specifico nome”, senza adottare un criterio chiaro e univoco. Egli dimostra che questa incertezza ha prodotto una giurisprudenza contraddittoria e soluzioni interpretative arbitrarie, con la conseguenza che il nome di sentenza diviene “una etichetta che copre diversa qualità di sostanze, senza fondamento e senza utile scopo”. La difficoltà estrema è quella di riuscire a ricostruire una disciplina organica che sia rispettosa della norma di diritto positivo e al contempo davvero utile e soddisfacente dal punto di vista scientifico e pratico.
Matteotti non concorda con quella dottrina e quella giurisprudenza di cassazione che legano il concetto di sentenza penale alla impugnabilità della decisione: si tratta di un'inversione del rapporto, di una “inesattezza sistematica e logica”, perché “non è la qualità di sentenza, che dipenda dal criterio della impugnabilità immediata, sibbene questo da quella; altrimenti appunto sentenze si sarebbero dette le decisioni soggette a immediata impugnabilità".
Secondo Matteotti, l’unico criterio valido per distinguere una sentenza da un’ordinanza dovrebbe essere la natura della decisione: una sentenza è tale solo se definisce il merito della pretesa penale ed è idonea a chiudere definitivamente il giudizio. Le dichiarazioni di incompetenza, invece, non esauriscono l’azione penale, ma determinano solo il trasferimento della causa a un altro giudice, e quindi non dovrebbero essere considerate sentenze.
Il problema del codice, spiega Matteotti, non è tanto legato a sviste o imperfezioni di alcune singole norme, “ma è anteriore e più profondo”, tanto che la qualifica di sentenza “diviene un puro nome per sé stesso nulla significante".
Dopo una critica alla penalistica civile, quella tendenza dei processualpenalisti di prendere a prestito istituti del diritto civile (contestazione già particolarmente forte in Nullità assoluta della sentenza penale), Matteotti conferma che, siccome le disposizioni del codice paiono inesatte e contraddittorie, tocca allora alla dottrina il compito di individuare una precisa definizione, mai, però, contro la legge, ma sempre nel suo rispetto.
Matteotti, allora, arricchisce il suo studio con cenni alla dottrina francese e italiana, ricostruendo in particolare la posizione di Arturo Rocco.
Infine, il giurista polesano evidenzia come la questione non sia solo teorica, ma abbia rilevanti implicazioni pratiche. L’incertezza sul concetto di sentenza influisce sull’impugnabilità dei provvedimenti e sulla formazione del giudicato.
Il penalista di Fratta conclude lo studio riassumendo tutti quei provvedimenti che possono ricadere sotto la definizione di sentenza:
- le decisioni che definiscono il giudizio, nel senso del procedimento sulla pretesa penale;
- le decisioni che definiscono l’istruzione, ossia la sentenza di non doversi procedere e quella di rinvio a giudizio. In questo caso, però, si specifica, il nome di sentenza viene conservato per pura convenzione legale ma senza un effetto giuridico particolare;
- alcune decisioni che, pur non definendo il procedimento penale, sono espressamente nominate nel codice come sentenze.
Inquadramento e contestualizzazione nel panorama giuridico
In questo studio sul concetto di sentenza, Matteotti, come di consueto, analizza con attenzione svariati articoli del codice di procedura penale del 1913, riconoscendo nel dato normativo – persino quando esso pare contraddittorio e poco preciso – il punto di partenza imprescindibile per ogni interpretazione e ricostruzione dogmatica.
Matteotti presta grande attenzione anche alle teorizzazioni della dottrina, arricchendo il contributo con richiami puntuali ed approfonditi agli autori più noti dell’epoca nel panorama italiano e con cenni a giuristi francesi.
In particolare, merita una menzione il riferimento esplicito al suo maestro, Alessandro Stoppato, che sosteneva la qualità di sentenza in capo ad ogni dichiarazione d’incompetenza, tesi contrastata dall’allievo senza mezzi termini, perché “non vi è formazione di giudicato sulla competenza".
Ma la critica di Matteotti diventa aspra e sferzante, con annessi passaggi ironici, nei confronti della scuola del tecnicismo giuridico, allora in rapida ascesa, i cui massimi esponenti furono Vincenzo Manzini e i fratelli Rocco.
Manzini viene per due volte citato in modo poco lusinghiero tra “coloro i quali si limitano alla glossa che nulla chiarisce”, accusato ironicamente di non avere “tempo di spiegare” perché tra due provvedimenti con il medesimo contenuto decida di chiamare l’uno sentenza e l’altro ordinanza. Si tratta di uno dei passaggi in cui la vis polemica di Matteotti emerge con più forza: fatto sorprendente, dato il tema tecnico e apparentemente distante dalle grandi controversie giuridiche dell’epoca.
Nei suoi studi e lavori processualpenalistici, e in particolare in questo, Matteotti dimostra un netto allontanamento da quegli indirizzi positivistici che lo avevano senz’altro affascinato, anni prima, quando si occupava di diritto penale sostanziale. Il continuo e scrupoloso richiamo al principio di legalità processuale come valore irrinunciabile mostra infatti una sensibilità del tutto diversa dai cultori della criminologia positivista.
Allo stesso tempo, però, la sua critica più pungente si rivolge proprio nei confronti degli esponenti del tecnicismo giuridico. In questo aspetto non si deve vedere una contraddizione: è certamente vero che egli stesso, nella sua analisi, aderisce al metodo tecnico di analisi del dato normativo e non accetta interpretazioni contrarie alla legge, ma si oppone al commento acritico, vuoto, apologetico del codice proposto invece da Manzini.
Matteotti certamente parte dal significato letterale della norma, ma da lì tenta poi di costruire un sistema che sia armonioso, razionale e rispettoso dei princìpi che sostengono il processo penale. Non ha timore nel criticare lacune o manchevolezze della legge. Anzi, ritiene che il compito dello studioso sia proprio quello di identificare gli aspetti problematici, per poter poi suggerire opportune modifiche e “preparare il diritto positivo di domani”. Per questa ragione non può apprezzare l’analisi di chi glossa il codice senza aggiungere nulla, limitandosi soltanto al “commento inanimato del diritto vigente” (così in Rendiconti analitici - G. Sabatini).
Ecco che quello di Matteotti, in contrapposizione alla tendenza rappresentata da Rocco e Manzini, può essere definito un “tecnicismo giuridico bene inteso” [D. Negri, Giacomo Matteotti custode della legalità processuale, in Giacomo Matteotti fra diritto e politica, Cierre, 2022, p. 51], perché pur “senza offesa alla legge” e sempre con un metodo rigoroso e logicamente inattaccabile, non rinuncia a sollevare - anche coraggiosamente - profili critici.
Considerazioni critiche
Matteotti sviluppa una visione della sentenza penale che prescinde dal momento in cui è emessa e che non si fonda sulla sua impugnabilità, concentrandosi invece sulla funzione che essa svolge nel processo. In particolare, egli sostiene che un provvedimento può essere considerato sentenza soltanto se è idoneo a definire il merito della pretesa penale e a chiudere definitivamente il giudizio. In questo modo, sono quindi escluse le dichiarazioni di incompetenza, che non esauriscono l’azione penale ma si limitano a trasferire la causa a un altro giudice. La sua analisi, pur partendo dal dato normativo, non si limita a una sterile esegesi del codice, ma si propone di ricostruire un sistema coerente.
Nonostante le svariate critiche ad una legge che fallisce nel tentativo di individuare in modo soddisfacente il concetto di sentenza, Matteotti continua a difendere il principio di legalità processuale, negando che si possano adottare interpretazioni in aperto contrasto con il significato letterale delle norme. Nel suo tentativo di costruire e descrivere un sistema omogeneo e organico, il penalista di Fratta non cede alla tentazione di sconfinare in interpretazioni contra legem. Partendo dal dato normativo, costruisce un sistema ordinato che unisce il rispetto per la littera legis e le sue intuizioni scientifiche sulle categorie processuali.
Influenza nelle opere successive e conclusione
Lo studio di Matteotti, definito “analisi acuta e industre tentativo di ricostruzione”, viene recensito l’anno successivo alla pubblicazione dalla rivista ad indirizzo moderatamente positivista di Florian [Redazione, voce Provvedimenti del giudice, in Rivista di diritto e procedura penale, Volume X, Parte prima, 1919, p. 232].
Recentemente, il contributo è stato citato e valorizzato in una monografia sulla sentenza penale, nella ricostruzione storica sulle critiche al tentativo definitorio del codice [L. Pressacco, Contributo allo studio della sentenza penale, Giappichelli, 2023, pp. 87, 95].
Le altre opere
Le altre schede
La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici - Riforme penitenziarie in Inghilterra - Il segreto delle confessioni in alcune legislazioni straniere - Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen. - Nullità assoluta della sentenza penale - Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale) - Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) - Classificazione degli incidenti di esecuzione - Rendiconti analitici - G. Sabatini: Principi di scienza del diritto penale. Catanzaro 1918, pag. 205 - Il pubblico ministero è parte