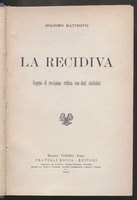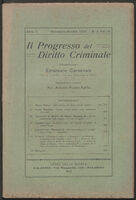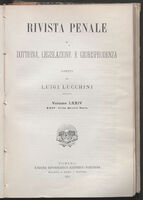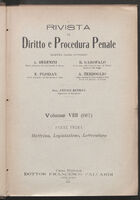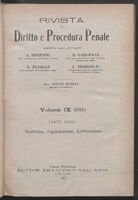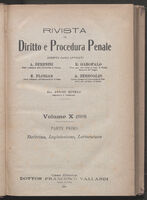Guida alla lettura - Il pubblico ministero è parte
Autore: Giacomo Matteotti Opera: Il pubblico ministero è parte In Rivista Penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Vol. XC, pp. 345-347 Diretta da Luigi Lucchini Anno: 1919
Sintesi dell’opera
Il pubblico ministero è parte è un breve scritto pubblicato nel 1919 su Rivista Penale. In questo contributo, Giacomo Matteotti espone la sua visione sulla figura del pubblico ministero, assumendo una posizione chiara e netta già a partire dal titolo.
Si tratta di un’opera che presenta una struttura semplice e un impianto argomentativo immediatamente efficace, ma non per questo banale.
Il testo si apre con una considerazione sul codice di procedura penale novellato nel 1913: osserva Matteotti che nessuna norma del codice osta a considerare il pubblico ministero come una parte, con tutti i corollari che da ciò derivano.
Dopo questa doverosa precisazione, la priorità di Matteotti è quella di dimostrare la scarsa consistenza dell’argomentazione - peraltro ancora oggi propugnata - secondo cui siccome il pubblico ministero agisce nel processo non per un interesse personale ed egoistico, bensì per l‘interesse collettivo, ciò lo rende più vicino al giudice che alle parti.
L’Autore certamente concorda sul fatto che il pubblico ministero rappresenta gli interessi della collettività e che, su questa base, gli sono affidati poteri legati all’importanza e alla delicatezza che caratterizzano la funzione che riveste quale rappresentante della pretesa punitiva. Tuttavia, Matteotti sostiene che il pubblico ministero debba essere considerato una parte proprio perché, in quanto organo della collettività, è il portatore dell’azione penale contro il soggetto ritenuto colpevole.
In modo consequenzialmente chiaro afferma: “parte nel processo penale è, secondo me, colui che può far valere o contro il quale è fatta valere la pretesa penale”.
Ecco allora che la pretesa punitiva dello stato, l’azione penale, è posta al centro del sistema e sono da considerarsi parti chi la esercita e chi la subisce, mentre il giudice è terzo ed egualmente distante da entrambe.
In questo senso, la necessarietà di ritenere il pubblico ministero come parte non comporta un voler degradare il suo interesse come privato e “partigiano”, quanto un voler esaltare la non negoziabile terzietà del giudice che decide su un bene così prezioso come la libertà personale della persona sottoposta al processo.
Ciò che colpisce maggiormente di questo breve contributo è la capacità di sintetizzare argomentazioni profonde e ancora attuali in poche frasi. Il rigore scientifico dell’opera emerge non soltanto nella chiarezza argomentativa, ma anche nell’integrazione di prospettive comparatistiche tramite riferimenti alla dottrina tedesca, particolarmente cara ai processualisti dell’epoca.
Inquadramento e contestualizzazione nel panorama giuridico
Il contributo di Matteotti si colloca nel periodo immediatamente successivo alla stagione di commissioni e proposte che ha portato, dopo un lungo e complesso iter, all’approvazione del Codice di procedura penale del 1913. Questo codice, destinato a rimanere in vigore per meno di vent’anni prima di essere sostituito dal codice del 1930 in epoca fascista, introduceva alcune novità significative, pur rimanendo ancora prevalentemente inquisitorio.
Il Codice del 1913 attribuisce al pubblico ministero un ruolo centrale sin dal primo articolo, nel quale gli è riconosciuta l’esclusiva titolarità dell’azione penale. La sua figura ricorre più volte nel testo normativo: in alcuni articoli (94 e 95) è citato insieme al giudice, mentre in altri è equiparato alle parti, come nell’art. 143, relativo agli incidenti di falso, e nel Titolo III in materia di impugnazioni (artt. 477 e ss.).
L’autentica natura del Codice del 1913 fu oggetto di un acceso dibattito dottrinale.
Alfredo Rocco lo considerava eccessivamente ispirato a princìpi liberali, giudicandolo caratterizzato da un “un principio individualistico di diffidenza verso le autorità”, considerato in seguito ovviamente incompatibile con il regime fascista, come esprimerà nella sua relazione sul progetto del codice del 1930.
Al contrario, invece, Luigi Lucchini, storico esponente della scuola classica, ne criticava le parti meno coraggiose e ancora sostanzialmente inquisitorie, tra le quali svettava proprio “l’equivoca supremazia del pm” e il suo non essere considerato parte. In questo senso, certi esponenti della dottrina denunciavano un eccessivo influsso delle idee positivistiche e inquisitorie, che hanno neutralizzato le proposte più arditamente liberali e tendenti ad un codice accusatorio.
In questo contesto c’è da sottolineare che, senza alcun timore reverenziale, Matteotti ha il coraggio di contraddire alcuni tra i più autorevoli esponenti della dottrina dell’epoca, come ad esempio Vincenzo Manzini, appartenente alla scuola del tecnicismo, da lui criticato più volte anche in altre occasioni (ad esempio, in modo molto forte, in Nullità assoluta della sentenza penale) e persino il suo stesso maestro Alessandro Stoppato. Quest’ultimo sosteneva la tesi, qui smentita da Matteotti, secondo cui l’interesse collettivo rappresentato dal pubblico ministero lo avvicinerebbe più al giudice che alle parti [A. Stoppato, Commento al codice di procedura penale, Volume quarto, Libro primo, Torino, 1918, p. 17].
Considerazioni critiche
Questo contributo sembra configurarsi come una risposta critica alla relazione al Re dell’allora Guardasigilli Camillo Finocchiaro-Aprile sul Codice di procedura penale del 1913, che escludeva perentoriamente la qualificazione del pubblico ministero come parte. Matteotti si pone in netta opposizione a questa affermazione, con un’opinione forte e controcorrente, un tratto distintivo tanto del suo impegno politico quanto della sua attività scientifica, sempre accompagnata da un inconfondibile rigore metodologico ed espositivo.
Il giurista polesano dimostra che il codice del 1913 “pretende di tenere ben distinto il p.m. dalle parti”, ma ci riesce soltanto nell’apparenza e non nella sostanza. La considerazione che rimane implicita è che in un sistema che vuole e dovrebbe, seppur gradualmente, trasformarsi da inquisitorio ad accusatorio, necessariamente il pubblico ministero deve essere considerato una parte e non, invece, un para-giudice.
Un aspetto di fondamentale importanza della sua analisi è il continuo richiamo alla lettura delle norme del codice vigente. Matteotti, da strenuo difensore del principio di legalità processuale, non propone una rilettura forzata delle disposizioni, né un’interpretazione contra legem. Al contrario, insiste sul fatto che il Codice di procedura penale del 1913, se interpretato correttamente, non si oppone a questa qualificazione, anzi la conferma. In questo senso, Matteotti tiene a sottolineare che la sua posizione è rispettosa della “sostanza delle norme”. Sul punto, l’Autore torna anche in conclusione, affermando che le norme del codice, “rettamente interpretate” non si oppongono, “anzi confermano la qualità di parte del p.m. [...] che nel processo entra come parte [...] portatrice dell’azione penale”.
Influenza nelle opere successive e conclusione
Le riflessioni di Matteotti, pur maturate in un contesto storico diverso, conservano una straordinaria attualità. La sua analisi del pubblico ministero come parte risuona ancora oggi nei dibattiti sulla separazione tra magistratura inquirente e giudicante, sulla struttura accusatoria del processo e sulla necessità di garantire la reale terzietà del giudice.
Non a caso, questo contributo è stato recentemente richiamato nel dibattito sulla riforma costituzionale appena approvata dal Parlamento sulla cosiddetta "separazione delle carriere". In tale contesto, è stato scritto che la sua è una visione “illuminata, potremmo dire, e assai avanzata" [S. Lorusso, Separazione delle magistrature giudicante e requirente e modello accusatorio, in Sistema Penale, 23 gennaio 2025, p. 5] e che “apriva fin dai primi anni del Novecento scenari inediti e di attuale modernità” [G. Canzio, Il pubblico ministero “parte imparziale”?, in Questione Giustizia, 1-2/2024, p. 106].
In questo senso, l’ultima fatica processualpenalistica di Matteotti rappresenta ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile nella contemporanea discussione sulla natura e ruolo del pubblico ministero che, lungi dall’essere terminata, è, al contrario, uno dei nodi cruciali per l’assetto del processo penale presente e futuro.
Le altre opere
Le altre schede
La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici - Riforme penitenziarie in Inghilterra - Il segreto delle confessioni in alcune legislazioni straniere - Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen. - Nullità assoluta della sentenza penale - Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare - Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale) - Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) - Classificazione degli incidenti di esecuzione - Rendiconti analitici - G. Sabatini: Principi di scienza del diritto penale. Catanzaro 1918, pag. 205