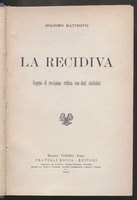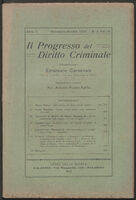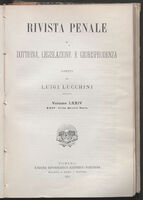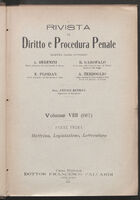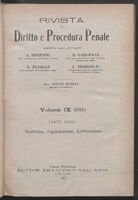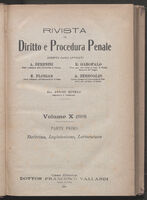Guida alla lettura - Classificazione degli incidenti di esecuzione
Autore: Giacomo Matteotti Opera: Classificazione degli incidenti di esecuzione In Rivista di Diritto e Procedura penale, Vol. X, Parte prima, pp. 114-137 Diretta da A. Berenini, R. Garofalo, E. Florian, A. Zerboglio Anno: 1919
Sintesi dell’opera
Questo studio di Giacomo Matteotti sugli incidenti di esecuzione, pubblicato nel 1919 sulla Rivista di Diritto e Procedura Penale, si propone di offrire una sistematizzazione chiara e rigorosa di un tema allora caratterizzato da notevoli incertezze concettuali e applicative. Secondo l’autore, le divergenze sul concetto stesso di incidente di esecuzione derivano da due opposte carenze metodologiche: da un lato, la tendenza di chi si limita alla mera esegesi dei frammenti normativi, senza saper costruire un sistema in grado di riconoscere e colmare le lacune; dall’altro, al contrario, un eccesso di astrazione, che conduce a formulazioni teoriche del tutto scollegate e irrispettose del dettato legislativo e del sistema processuale.
Matteotti adotta un approccio analitico, classificando gli incidenti di esecuzione in quattro gruppi principali che si “possono nettamente distinguere”.
- Il primo gruppo comprende gli incidenti volti a chiarire il contenuto della sentenza. Matteotti specifica che per questi provvedimenti deve ritenersi “escluso ogni apprezzamento o arbitrio del giudice di esecuzione, il quale deve limitarsi a rilevare una volontà già manifesta” nella sentenza.
- Il secondo gruppo è composto dagli incidenti relativi all’accertamento di fatti successivi alla sentenza.
- Il terzo gruppo è relativo agli incidenti derivanti da contestazioni delle parti sull'esecuzione della pena.
- Il quarto gruppo, infine, comprende gli incidenti che determinano una modifica dell’esecuzione.
Questa classificazione, pur riconoscendo la possibilità di ulteriori suddivisioni interne, consente di distinguere in modo netto le diverse funzioni che gli incidenti di esecuzione assolvono nell’ambito del processo penale.
Il giurista polesano afferma che i casi indicati nei gruppi II e IV sono tassativi, mentre quelli dei gruppi I e III sono solo esemplificativi.
Matteotti elogia poi la “stretta osservanza della legalità”, auspicando la riduzione al minimo degli “incidenti delle prime specie”. L’esecuzione viene vista come “continuazione della cognizione”: fase del tutto separata e che non si pronuncia su elementi della cosa giudicata, ma si occupa invece della “cognizione del delinquente”, ossia della individualizzazione del trattamento.
L’analisi prosegue esaminando la forma del provvedimento di esecuzione. Chiarito che si tratta di ordinanza, si specifica però che l’ordinanza di esecuzione ha “valore effettivo e immediatamente proprio, simile a quello della sentenza". La differenza sta nel fatto che non si tratta di un giudizio del giudice sulla pretesa penale, perché non decide su colpevolezza o punibilità, ma semplicemente attua, in conformità alla legge, la volontà della sentenza di condanna.
Matteotti si occupa poi del giudice dell’esecuzione e avanza una proposta di riforma. Per quanto riguarda gli incidenti dei gruppi I e III ritiene che occorrerebbe l’identità personale del giudice che ha pronunciato la sentenza, perché è colui che ne conosce meglio il contenuto. Relativamente invece ai gruppi II e IV, il penalista auspica la creazione di una magistratura specializzata che si occupi di esecuzione.
Dopo un interessante cenno al ricorso per cassazione in questa materia, Matteotti conclude con un’ultima riflessione che mette in evidenza l’importanza del ruolo del giudice dell’esecuzione, argine all’arbitrio del potere amministrativo.
Inquadramento e contestualizzazione nel panorama giuridico
La disciplina dell’esecuzione nel codice di procedura penale Finocchiaro Aprile del 1913 è delineata nella prima parte dell’opera, dove l’autore classifica i diversi tipi di incidenti di esecuzione e ne indica i relativi riferimenti normativi.
Rispetto al codice Zanardelli, che non conteneva una disciplina organica della fase esecutiva, la riforma del 1913, pur senza fornire una vera e propria definizione degli incidenti di esecuzione, ha almeno “raggiunto lo scopo di dare delle direttive uniformi” per la loro risoluzione [G.B. De Mauro, Gli incidenti di esecuzione, in Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Secondo supplemento, 1916, p. 13].
Il presente contributo è uno dei più ricchi di note e riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza, di legittimità e di merito, e inoltre contiene un accenno alla scienza giuridica tedesca (Binding). Ciò lascia emergere il rigore dell’approfondimento e dello studio della procedura penale durante il confino messinese di Matteotti.
Sul piano dottrinale, egli critica la costruzione di Aloisi e Mortara sui poteri dell’autorità amministrativa, che accentuerebbe il già “deplorevole ibridismo di certi organi e istituti”, nonché la visione di Lanza, che “fa della esecuzione una ricognizione di quello che è già conosciuto, e anzi una revocazione o una impugnazione della cognizione" (sul punto, si veda anche l'analoga critica a Lanza in Nullità assoluta della sentenza penale).
La giurisprudenza, invece, è richiamata soprattutto nella prima parte del contributo, dove l’autore distingue i quattro gruppi di incidenti di esecuzione.
Considerazioni critiche
Uno dei temi centrali di questo contributo è la distinzione tra amministrazione e giurisdizione in materia di esecuzione penale. Matteotti esprime una forte preoccupazione che le libertà possano essere compresse senza adeguato controllo giurisdizionale, bensì tramite decisioni arbitrarie del potere esecutivo, sfuggendo così a limiti e controlli. Egli ribadisce che “l’unica autorità che oggi ancora esamini e decida i problemi della esecuzione [...] è il giudice. E a lui per ora ricorriamo”. Al contrario, infatti, affidare un provvedimento all’amministrazione significa abdicare alla “discrezione più indiscreta, all'arbitrio, a criteri che ormai più nulla hanno di comune con i fini e l'essenza della pena”.
Di particolare interesse è poi la proposta di istituire un giudice specializzato per la fase esecutiva, con il compito di individualizzare il trattamento del condannato. Sebbene Matteotti ipotizzasse una competenza su questioni oggi ancora riconducibili al giudice dell’esecuzione (gruppi II e IV della sua classificazione), la sua intuizione può essere interpretata come un ulteriore tentativo di sottrarre la fase esecutiva alla discrezionalità dell’amministrazione. In questa prospettiva, il suo pensiero sembra anticipare, almeno in parte, l’esigenza che porterà, oltre cinquant’anni dopo, all’istituzione della magistratura di sorveglianza (L. 354/1975).
Un ultimo accenno degno di nota riguarda il ricorso per cassazione. Il giurista di Fratta afferma che esso è sempre proponibile contro l’ordinanza di esecuzione, poiché il vizio di tale provvedimento, “per la sua stessa singolare efficacia, offende immediatamente i diritti delle parti con la stessa gravità d’una sentenza illegale”. A ben vedere, si tratta di una chiara anticipazione dell’art. 111 Cost., che prevederà la ricorribilità alla Suprema corte non solo delle sentenze, ma di tutti i “provvedimenti sulla libertà personale”.
Influenza nelle opere successive e conclusione
Un anno dopo la pubblicazione, questo contributo di Matteotti viene brevemente recensito su un’altra rivista. Nonostante si riconosca nell'opera “un po’ troppo di quella voluttà classificatrice, [...] che poi non conclude a niente di veramente utile e positivo”, viene altresì lodato “il talento acuto e geniale del valoroso autore” [Redazione, in Rivista Penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Vol XCI, I, 1920, p. 199].
Sebbene non vi siano richiami espliciti all’opera di Matteotti, negli stessi anni è da segnalarsi un importante contributo di Pietro Mirto, che si propone di ricostruire in modo organico la materia dell’esecuzione penale [P. Mirto, Alla ricerca di un concetto scientifico sull’esecuzione processuale penale, in Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Vol. XCIV, 1921, p. 197].
Più recentemente, lo scritto di Matteotti è citato in una voce del Digesto delle discipline penalistiche [M. Antinucci, Procedimento per la distruzione delle cose illegali, in Digesto delle discipline penalistiche, Ottavo aggiornamento, 2014].
Le altre opere
Le altre schede
La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici - Riforme penitenziarie in Inghilterra - Il segreto delle confessioni in alcune legislazioni straniere - Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen. - Nullità assoluta della sentenza penale - Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare - Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale) - Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) - Rendiconti analitici - G. Sabatini: Principi di scienza del diritto penale. Catanzaro 1918, pag. 205 - Il pubblico ministero è parte