Mappa dei nomi
Questa sezione presenta i principali protagonisti del panorama giuridico con cui Giacomo Matteotti si confronta nei suoi scritti. Vengono delineati cenni biografici ed è proposto un approfondimento sul loro ruolo e sulla relazione che hanno avuto con Matteotti nel contesto in cui si colloca la sua elaborazione penalistica.
Alessandro Stoppato (Genova, 31 dicembre 1858 – Milano, 23 giugno 1931):
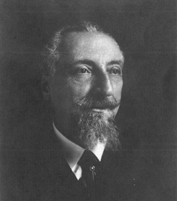
Alessandro Stoppato si laureò con lode in Giurisprudenza all’Università di Padova nel 1880, allievo di Gian Paolo Tolomei. Due anni dopo si iscrisse all’albo degli avvocati, avviando una carriera che lo vide impegnato sia nella professione forense sia nell’attività accademica.
Come avvocato penalista, Stoppato fu protagonista di processi di grande risonanza nazionale. Tra i suoi casi più noti figurano la difesa di Luigi Favilla, importante funzionario pubblico, e di Ferruccio Macola, giornalista e deputato. Tuttavia, il processo che gli garantì maggiore visibilità fu il caso Murri (1905), relativo all’omicidio del conte Francesco Bonmartini, vicenda in cui rappresentò la parte civile.
Parallelamente, Stoppato sviluppò una intensa attività scientifica. Dopo le prime pubblicazioni, ottenne nel 1885 la libera docenza in Diritto e Procedura Penale presso l’Università di Padova.
Stoppato aderì con convinzione alla scuola classica del diritto penale, non senza coltivare però un pensiero originale.
Dal 1887 insegnò all’Università di Bologna, dove, nella prolusione Dell’elemento etico nel magistero penale, ribadì la centralità del principio di imputabilità morale come fondamento della responsabilità penale. Tale convinzione venne riaffermata anche nel discorso inaugurale dell’anno accademico 1908-1909, La scuola giuridica italiana e il progresso del diritto penale.
Di orientamento liberale-conservatore, nel 1905 fu eletto deputato e collaborò con Lodovico Mortara alla riforma del codice di procedura penale, di cui fu relatore alla Camera nel 1912 e che poi prenderà il nome del Guardasigilli Finocchiaro Aprile.
Incontrò Matteotti proprio all’Università di Bologna dove fu relatore della sua tesi sulla recidiva nel 1907. I due ebbero un rapporto stretto: fu proprio Stoppato a sostenere Matteotti nella pubblicazione della monografia, come testimonia la corrispondenza tra i due [G. Matteotti, S. Caretti (a cura di), Epistolario (1904-1924), Plus, 2012], nonché ad accoglierlo a collaborare nel proprio studio legale.
Anche durante il confino di Matteotti a Messina, i due mantennero i contatti, discutendo di questioni giuridiche affrontate nei suoi scritti. Più volte Stoppato tentò di convincerlo a intraprendere la carriera accademica, riconoscendone il valore scientifico.
Stoppato trasfuse le proprie convinzioni di penalista anche nell’impegno sociale e filantropico occupandosi di recupero di ex detenuti, in particolare minorenni.
Morì a Milano la notte del 23 giugno 1931.
Dopo l’assassinio di Matteotti, scrisse su di lui parole elogiative e commoventi:
“Diventammo amici. Io gli ho voluto bene; e se lo meritava per la bontà dell'animo, la nobiltà dell'intelletto,la rettitudine del carattere. Io pensavo politicamente in modo profondamente diverso da lui, ma io e lui tanto più ci siamo moralmente avvicinati l'un ľaltro quanto più il nostro pensiero politico ci distaccava.[...] Egli aveva dolcezze squisite di sentimento. A me, anche dopo che finimmo di esserci vicini, parlava spesso con tenerezza della madre, della sposa e dei figli suoi ai quali era legato da una affezione commovente. Sentiva e parlava da padre di famiglia esemplare. Di eletta intelligenza studiava con amore verace per la ricerca scientifica; e con alto spirito di illuminata libera impassibilità, decideva e sosteneva la sua opinione. Aveva forza per raggiungere una posizione scientifica dalla quale la politica temporaneamente lo distraeva, ed aveva raggiunta già una seria reputazione quale giurista colto e assennato. La sua morte atrocemente tragica ha tolto alla scienza una forte promessa; agli amici un amico onesto e leale; alla famiglia sua un capo esemplare. Egli, che avrebbe potuto vivere senza cure e molestie, preferì combattere per il trionfo dei suoi ideali; e, come non di rado avviene in questo mondo triste, vi raccolse amarezza e odio crudele!” [A. Stoppato, in Comitato centrale delle opposizioni (a cura di), Giacomo Matteotti. Nel I° anniversario del suo martirio, 1925, p. 206].
Eugenio Florian (Venezia, 25 novembre 1869 – Venezia, 28 marzo 1945):

Eugenio Florian si laureò in Giurisprudenza all’Università di Padova nel 1892 con una tesi sui reati contro l’onore. Il suo lavoro fu inserito nella Biblioteca antropologico-giuridica degli editori Bocca di Torino e, ampliato negli anni successivi, venne poi pubblicato nel 1893 con il titolo La teoria psicologica della diffamazione. Studio sociologico-giuridico.
Seguace della scuola positiva del diritto penale, Florian divenne uno dei suoi massimi esponenti. Il suo approccio si concentrava sull’elemento soggettivo del reato piuttosto che su quello oggettivo, ritenendo centrale l’analisi dei moventi dell’agente. Nella sua concezione, il diritto penale doveva avere la funzione di preservare l’utilità sociale, distinguendo tra azioni vantaggiose per la collettività e comportamenti propri degli elementi antisociali.
Nella sua carriera accademica insegnò Diritto Penale e Procedura Penale in diverse università italiane, tra cui Urbino, Sassari, Cagliari, Messina, Siena, Modena e Torino, mentre continuava a svolgere la professione forense.
Impegnato anche in politica, fu consigliere comunale e provinciale di Venezia e nel 1922 venne eletto deputato per il Partito Socialista Italiano, insieme a Giacomo Matteotti.
Nel 1910 fondò, con Adolfo Zerboglio, la Rivista di diritto e procedura penale, che nel 1921 si fuse con La Scuola positiva, di cui fu direttore per molti anni.
Ebbe un rapporto cordiale e di reciproca stima con Matteotti, pubblicando diversi suoi lavori sulla Rivista di diritto e procedura penale. I due intrattennero un frequente carteggio e si incontrarono personalmente a Messina nel 1917, quando Matteotti vi fu confinato per la sua opposizione alla guerra, mentre Florian insegnava all’Università [G. Matteotti, S. Caretti (a cura di), Lettere a Velia, Pisa University Press, 2021, p. 188].
Morì a Venezia il 28 marzo 1945.
Il suo ricordo di Matteotti, un anno dopo l'assassinio, è accorato e mette in evidenza la sue qualità di studioso del diritto penale:
“Giacomo Matteotti ebbe mente di giurista. Erano del suo ingegno, fra altre nobilissime, alcune doti, che fanno il giurista: l’acutezza e la limpidezza del pensiero, l’austerità del metodo, e, soprattutto, una potente facoltà di critica ed insieme di sistemazione e sintesi. [...] Certo fece ben poco; ma il poco che fece non sarà travolto dall’oblio ed anzi rimarrà indice d’un’attitudine scientifica di prim’ordine, nella quale il fervore di critica e innovazione, rifuggendo da ogni improvvisazione facilona (oggi tanto in voga!), temperava e quasi castigava se stesso con la severità e l’oculatezza della ricerca.
I giuristi e specialmente i penalisti italiani possono, pertanto, reclamare, almeno in parte, come patrimonio loro la memoria santa del purissimo martire, che morendo per la libertà, testimoniò ancora una volta che diritto e libertà sono termini indissolubili, beni ideali eterni” [E. Florian, in Comitato centrale delle opposizioni (a cura di), Giacomo Matteotti. Nel I° anniversario del suo martirio, 1925, p. 192].
Luigi Lucchini (Piove di Sacco, 10 giugno 1847 – Limone sul Garda, 28 settembre 1929):

Allievo, come Stoppato, di Gian Paolo Tolomei, Luigi Lucchini si laureò in Giurisprudenza all’Università di Padova nel 1869. Due anni dopo iniziò a esercitare la professione forense a Venezia, senza tuttavia abbandonare l’attività di ricerca. Pubblicò due monografie e ottenne l’insegnamento di Diritto Penale presso la Scuola Superiore di Commercio di Venezia. Nel 1874 fondò la celebre Rivista Penale e nel 1878 divenne professore ordinario di Diritto e Procedura Penale all’Università di Siena, per poi trasferirsi a Bologna.
Venne eletto deputato per la prima volta nel 1892 nel primo collegio di Verona, tra le file della Sinistra Storica, vicina a Giuseppe Zanardelli. Quasi contemporaneamente, lasciò l’insegnamento universitario per dedicarsi interamente all’attività politica e giudiziaria. Nel 1893 divenne consigliere di Cassazione.
Nominato senatore nel 1908, affiancò l’incarico politico a quello in magistratura, senza mai abbandonare il ruolo di direttore della Rivista Penale. Ebbe qualche frizione con l’Associazione Generale dei Magistrati Italiani, ritenendo che la figura del giudice fosse profondamente diversa da quella degli altri funzionari statali. Intorno al 1910 si scontrò anche con l’avvocatura, in particolare con Gennaro Escobedo.
Nei primi anni Venti si schierò contro i governi liberali, guardando con un certo interesse all'ascesa del fascismo in funzione anti socialista [In tal senso, si v. L. Lucchini, Il socialismo militante in Italia è un delitto comune, in Rivista penale di dottrina legislazione e giurisprudenza, Vol XCV, 1922, p. 21].
Cambiò opinione negli anni successivi, chiedendo giustizia per l’assassinio di Matteotti e denunciando le violenze delle milizie fasciste. Subì un processo nel 1926 per un articolo considerato ingiurioso nei confronti di Mussolini e si ritirò a Limone sul Garda, dove morì nel 1929.
Nel 1917, da direttore della Rivista Penale, invitò Giacomo Matteotti a inviargli contributi per la pubblicazione [G. Matteotti, S. Caretti (a cura di), Epistolario (1904-1924), Plus, 2012, p. 95], che poi effettivamente accolse. I due giuristi ebbero un rapporto di reciproca stima, incrinato per un breve periodo solo dalla pubblicazione, nel 1922, del citato articolo di Lucchini contro il socialismo [Sul punto, G. Matteotti, S. Caretti (a cura di), Scritti giuridici, Nistri-Lischi, 2003, p. 8].
Anche Lucchini, poco dopo l'omicidio Matteotti, ricordò lo stimato collega, riportando la risposta del deputato socialista alla sua lettera in cui il Professore lo pregava di ritirarsi dalla politica per dedicarsi all'attività universitaria.
"È quindi avvenuta la tragedia Matteotti. Niuno più di noi ne è rimasto sgomento e dolente. Era stato uno studioso assiduo e valente delle nostre discipline, e la Rivista si compiace di aver ospitato vari suoi pregevoli lavori. Da che lo avevano eletto deputato e si era consacrato con fervore alla politica, egli avea disertato la scienza. Or chi dirige questa Rivista, e lo teneva in molta considerazione per l’ingegno e per la cultura, non cessava di stimolarlo perché ritornasse ai prediletti studi. Ma la passione politica lo aveva ormai conquiso, ed egli ci scriveva da ultimo una lettera, che inseriamo in omaggio alla sua memoria e come segno del nostro compianto.
«Illustre Professore,
Ritrovo, qui Ia sua lettera gentile, e non so come ringraziarLa delle espressioni a mio riguardo. Purtroppo non vedo prossimo il tempo nel quale ritornerò tranquillo agli studi abbandonati.
Non solo la convinzione, ma il dovere oggi mi comanda di restare al posto più pericoloso, per rivendicare quelli che sono, secondo me, i presupposti di qualsiasi civiltà e nazione moderna.
Ma quando io potrò dedicare ancora qualche tempo agli studi prediletti, ricorderò sempre la profferta e l’atto cortese che dal Maestro mi sono venuti nei momenti più difficili.
Con profonda osservanza
10 maggio 1924
Dev.mo G. MATTEOTTI»".
[L. Lucchini, Chi semina vento raccoglie tempesta, in Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Vol. C, 1924, p. 101].
[L. Lucchini, Chi semina vento raccoglie tempesta, in Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Vol. C, 1924, p. 101].
Vincenzo Manzini (Udine, 20 agosto 1872 – Venezia, 16 aprile 1957)
Vincenzo Manzini si laureò in Giurisprudenza all’Università di Padova nel 1895. Divenne professore ordinario di Diritto e procedura penale, insegnando nelle Università di Ferrara, Sassari, Siena, Torino, Pavia e Padova. Nel 1938 fu chiamato a Roma per ricoprire la prima cattedra di Procedura penale. Oltre all'attività accademica, fu anche avvocato, iscritto all'Ordine di Padova fino alla morte.
Manzini fu uno dei più importanti penalisti del primo Novecento. Lavorò sulla riforma dei codici penali militari, nonché al codice di procedura penale e al codice penale assieme ad Alfredo Rocco e Ugo Aloisi.
Fu il più importante esponente dalla Scuola del cosiddetto tecnicismo giuridico, di cui fu definito "il sommo sacerdote" [A. A. Calvi, Ugo Spirito criminalista. Riflessioni sulla terza edizione della "Storia del diritto penale italiano", in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, III-IV, 1975, p. 823].
Nonostante l'inquadramento nella scuola del tecnicismo, il pensiero di Manzini non è privo di evoluzioni o complessità. Nel 1900, nel discorso inaugurale per l'Anno accademico all'Università di Ferrara, il penalista elogia "il grande nostro Carrara", cita con ammirazione Luigi Lucchini e, al contrario, riserva parole molto dure per Enrico Ferri e il "bieco stendardo della difesa sociale" [V. Manzini, La crisi presente del diritto penale, in V. Manzini, Scelta di scritti minori, Unione tipografico - editrice torinese, 1959, pp. 292, 296, 300, 302].
Se dunque in questa prima fase è possibile leggere una forte avversione al positivismo e maggiori affinità con i valori liberali della scuola classica, successivamente Manzini, iscritto dal 1925 al Partito fascista, assume posizioni radicalmente diverse: sostiene la pena di morte, invece avversata in gioventù; si contrappone alla presunzione d'innocenza dell'imputato, che aveva precedentemente sostenuto e valorizza in chiave illiberale quelle ragioni di difesa sociale contro cui così duramente si era scagliato nella prolusione del 1900.
Anche per queste ragioni, Manzini fu spesso definito certamente autorevole, viste le indubbie qualità di analisi ed elaborazione del pensiero, ma "giurista di regime" [Tra gli altri, F. Giunta, La prescrizione del reato: ovvero la causa estintiva che visse due volte, in Criminalia, 2017, p. 378].
Il suo rapporto con Matteotti non fu cordiale. Il penalista polesano fu critico delle tesi di Manzini nella sua monografia sulla recidiva e la risposta di quest'ultimo fu piuttosto secca: "Matteotti si limita a ruminare le idee di Stoppato in tutto ciò che non costituisce pedestre indagine statistica" [Riportato da S. Caretti, L'idea che non muore, in Questione Giustizia, 7 giugno 2024].
Forse anche a causa di questi vecchi dissidi, ma certamente anche per la sua ferma adesione al fascismo, le parole di Manzini sull'omicidio di Matteotti, che introducono l'arringa difensiva per gli assassini del deputato socialista, risuonano molto dure:
"L’immenso scalpore, sì a lungo durato intorno al fatto in discorso (delitto Matteotti), fa singolare contrasto con la indifferenza ostentata dai sedicenti paladini della morale e della libertà per le tante vittime della criminalità politica dell’immediato dopo-guerra… Queste stragi di disinteressati fautori di un’idea, in tempi di roventi lotte politiche, valevano bene l’uccisione di un deputato, capo-partito, che della politica faceva professione esclusiva, ritraendone onori e vantaggi, e che da sé stesso si era posto in condizione di vivere pericolosamente. Ma politica e malafede sono spesso la stessa cosa, e questo spiega il perché della frenetica speculazione sulla morte di Matteotti, morte che si volle considerare, non quale un incerto del mestiere di demagogo, ma addirittura come un attentato contro il popolo" [V. Manzini, Prefazione, in R. Farinacci, Il processo Matteotti alle Assise di Chieti. L'arringa di Roberto Farinacci, Cremona, 1926, p. IV].
Bibliografia e immagini
G. Matteotti, S. Caretti (a cura di), Scritti giuridici, Nistri-Lischi, 2003.
G. Matteotti, S. Caretti (a cura di), Epistolario (1904-1924), Plus, 2012.
G. Matteotti, S. Caretti (a cura di), Lettere a Velia, Plus, Pisa University Press, 2021.
Comitato centrale delle opposizioni (a cura di), Giacomo Matteotti. Nel I° anniversario del suo martirio, Morara, 1925.
L. Lucchini, Il socialismo militante in Italia è un delitto comune, in Rivista penale di dottrina legislazione e giurisprudenza, Vol XCV, 1922, p. 21.
L. Lucchini, Chi semina vento raccoglie tempesta, in Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Vol. C, 1924, p. 101.
V. Manzini, La crisi presente del diritto penale, in V. Manzini, Scelta di scritti minori, Unione tipografico - editrice torinese, 1959, p. 291.
F. Giunta, La prescrizione del reato: ovvero la causa estintiva che visse due volte, in Criminalia, 2017, p. 378
V. Manzini, Prefazione, in R. Farinacci, Il processo Matteotti alle Assise di Chieti. L'arringa di Roberto Farinacci, Cremona, 1926, p. IV.
Immagini tratte dall'Archivio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica:
Ritratto di Alessandro Stoppato - Licenza CC BY 3.0 IT
Ritratto di Eugenio Florian - Licenza CC BY 4.0
Ritratto di Luigi Lucchini - Licenza CC BY 3.0 IT
