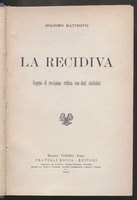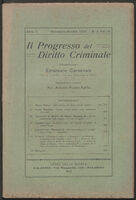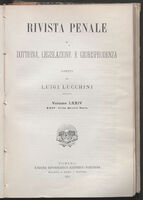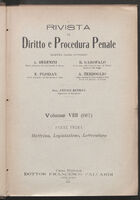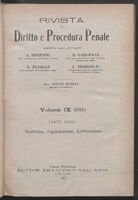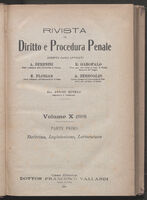Guida alla lettura - La recidiva
Autore: Giacomo Matteotti Opera: La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici, Torino, Bocca, 1910 Anno: 1910
Sintesi dell’opera
La monografia sulla recidiva è senz’altro l’opera più importante della produzione del Matteotti penalista. Questo volume, pubblicato nel 1910, costituisce un'evoluzione delle osservazioni avanzate dall’autore nella tesi di laurea, discussa presso l’università di Bologna nel 1907 sotto la guida del suo maestro Alessandro Stoppato.
L’opera si apre con un’introduzione in cui viene brevemente presentata una ricostruzione storica della recidiva dall’antichità fino al Novecento. La speciale risposta penale alla ricaduta nel reato viene giustificata dalla massima di esperienza secondo cui in ogni “aggruppamento sociale la replicata infrazione di una norma di condotta” aggrava “quella disapprovazione semplice che era seguita la prima volta”.
Nella parte prima, Matteotti raccoglie e ragiona su I dati della recidiva. Dopo le classificazioni della recidiva nei principali stati europei, con numeri e percentuali di condannati e recidivi, vengono presentate tabelle contenenti statistiche in base al delitto commesso e sui fattori della delinquenza e della recidiva. Vengono esaminati il sistema penale come fonte di recidiva, i vizi sociali ed economici; si procede poi con la classificazione per geografia, etnia, età, sesso e istruzione. La presentazione dei dati è accompagnata da una ricostruzione ragionata della dottrina italiana ed europea sui fattori scatenanti la recidiva. L’autore prende posizione sulle opinioni dei commentatori precedenti ed introduce brevemente il concetto del “fattore personale permanente”, caposaldo del suo sistema sulla recidiva, su cui focalizzerà l’attenzione più avanti.
La seconda parte, intitolata Le teorie della recidiva, è dedicata all’analisi critica delle principali correnti dottrinali in materia. Matteotti esamina le diverse teorie sviluppate fino a quel momento, partendo dalle posizioni abolizioniste fino alla visione dei positivisti, non mancando di evidenziare criticità e limiti.
Il giovane penalista polesano concentra poi la sua attenzione sulla temibilità del recidivo, sviluppando più organicamente la sua teoria sul fattore personale permanente. Matteotti critica gli estremi di ritenere ininfluenti o, al contrario, unicamente responsabili i fattori sociali. Nella sua visione, il delitto è “prodotto dall’incontro di due linee”: una è l’occasione, l’altra è da individuarsi proprio nel fattore personale permanente, inteso come la “tendenza antigiuridica del carattere individuale, cui il diritto penale ha il compito specifico di opporsi”. L’autore si interroga poi sul criterio della temibilità e sottolinea che occorre sempre curarsi che tale indagine non invada il campo della morale, del tutto estraneo al diritto penale. Al contrario, siccome non si puniscono le tendenze, ma soltanto “le tendenze non frenate”, ecco che il fattore personale permanente rappresenterebbe una causa di immoralità non punibile di per sè, “ma alla quale il delitto viene appunto a imprimere il marchio della specificità, a dirne chiara la posizione antigiuridica, rendendo legale e necessario l'intervento del diritto penale”. In questo contesto, la recidiva viene considerata come indizio più sicuro della permanenza di una tendenza non genericamente immorale, “ma specificamente antigiuridica”, come emerge dal ripetersi dei delitti. La recidiva, dunque, è la prova di sussistenza del fattore personale permanente; è un sintomo dal quale si intuisce con ragionevole certezza questa permanente tendenza antigiuridica del soggetto, al di là delle circostanze o occasioni contingenti del singolo illecito: da ciò discende la meritevolezza di una pena e, talvolta, la necessità di eliminazione (intesa come isolamento del reo dal resto della società). Le considerazioni del penalista si concentrano allora sulla incorreggibilità dei recidivi: sulla base dei dati presentati nella prima parte dell’opera, Matteotti afferma che i recidivi ricadranno quasi certamente ancora nel delitto dopo la commissione del terzo reato e, pertanto, di norma dovrebbero essere considerati non più recuperabili.
La parte terza, infine, tratta de I mezzi penali contro la recidiva. Matteotti torna ad interrogarsi sullo scopo della pena, escludendo che l’unica o principale funzione sia quella puramente retributiva. Se lo scopo del diritto penale è la tutela dei beni giuridici, la pena giusta dev’essere quella utile, adeguata al fine, in un'ottica che si avvicina a quella di Von Liszt (di pena “giusta e utile” Matteotti scriverà ancora, qualche anno dopo, in Rendiconti analitici - G. Sabatini). Ecco che, allora, il giovane penalista elenca tre scopi da perseguire con la pena: l’intimidazione, l’emenda e l’eliminazione.
Dopo essersi brevemente occupato del problema della delinquenza giovanile, analizza le pene alternative alla detenzione, intuendone le potenzialità, sebbene quello del suo tempo fosse ancora un sistema estremamente carcerocentrico.
I due capitoli finali affrontano il tema della pena perpetua per gli incorreggibili e dell’indeterminate sentencing.
Matteotti si schiera favorevolmente all’applicazione dell’ergastolo per i recidivi considerati incorreggibili, ritenendo che, falliti gli altri scopi della pena, per loro purtroppo sia perseguibile soltanto l'eliminazione. La sua posizione viene però mitigata dalla possibilità, che va sempre garantita a tutti i condannati, di ottenere la liberazione condizionale nell’eventualità di avvenuta risocializzazione, da individuarsi caso per caso tramite l’osservazione durante il trattamento carcerario: Matteotti afferma che a nessun reo può essere tolto uno “spiraglio luminoso di speranza”, con un’espressione che ricorda tanto le costruzioni della più recente dottrina e giurisprudenza, anche sovranazionale, in tema di ergastolo cosiddetto ostativo [su tutte, Corte EDU, 13 giugno 2019, Viola c. Italia].
Pur con qualche perplessità sulle modalità attuative, il giurista polesano si dice favorevole anche alla introduzione della condanna a pena indeterminata, da definirsi in sede di esecuzione sulla base della risposta del reo al trattamento carcerario, tesi all’epoca sostenuta dai positivisti.
Inquadramento e contestualizzazione nel panorama giuridico
Dal punto di vista normativo, nel codice Zanardelli, all’epoca in vigore, la recidiva era disciplinata dagli artt. 80 e seguenti, nel Libro I - Titolo VIII, in cui sono indicati i vari casi e i relativi aumenti di pena.
In quegli anni si trattava di un tema centrale nella discussione penalistica. Già tema classico di fondamentale importanza, assume poi ulteriore rilievo con l’ascesa nel panorama giuridico della criminologia di stampo positivistico, che pone particolare attenzione alla personalità del reo e allo studio dei dati relativi al fenomeno criminale. Il “metodo” positivista di Matteotti, sempre attento allo studio dei numeri, emerge in modo evidente già dal sottotitolo della monografia: “saggio di revisione critica con dati statistici”. Nonostante questo, però, i contenuti non sono invece del tutto inquadrabili in una adesione alle ideologie proprie della scuola positiva.
Nella seconda parte della monografia, Matteotti si occupa della presentazione delle diverse teorie dottrinali intorno alla recidiva. In particolare, vengono approfondite:
- La teoria classica abolizionista, che nega qualsiasi differenziazione di trattamento tra primari e recidivi, fondata su un’interpretazione rigorosa del ne bis in idem e su una concezione del diritto penale legata esclusivamente al disvalore del fatto e non alla personalità o pericolosità del reo.
- La teoria classica carrariana dell’insufficienza della pena, secondo cui la recidiva implica una maggiore pervicacia dell’elemento soggettivo del reo che ha continuato a delinquere dopo la prima condanna e dunque la necessità di una pena più severa, dal momento che la precedente sanzione non è stata sufficiente.
- La teoria neoclassica, bersaglio di una dura critica di Matteotti, che viene definita come il risultato di "un frettoloso innesto delle malcomprese nuove idee positiviste sulle classiche antiche". Secondo questa teoria, la recidiva sarebbe in realtà da inquadrare addirittura in un'attenuante, poiché il reo abituale agirebbe condizionato da fattori esterni rispetto alla sua libertà di scelta, comportando così un affievolimento della volontà criminale e dunque della colpevolezza. Dal momento però che la coscienza sociale teme proprio questo genere di criminalità e chiede risposte alla giustizia, alcuni di questi autori proponevano di istituire misure di sicurezza amministrative, parallele al diritto penale ma con processi meno garantiti, per limitare la pericolosità sociale dei più incalliti recidivi, proposta particolarmente avversata dagli esponenti della scuola classica ma anche dallo stesso Matteotti.
- La posizione degli eclettici francesi viene riassunta nella formula di unire giustizia e utilità della pena, considerando sia la maggiore colpevolezza, sia le esigenze di tutelare la pubblica sicurezza. In contrapposizione a queste teorie, considerate valide, Matteotti fa poi riferimento a Manzini, accusato di ipocrisia perché, sebbene formalmente contrario alle tesi positiviste, poi sostanzialmente le imita nella valutazione del “criterio della pericolosità, della temibilità" del recidivo.
- La ricostruzione dei positivisti italiani, ovviamente orientata al lato della pericolosità soggettiva dei recidivi, viene ritenuta soltanto abbozzata e non troppo approfondita nei principali autori dell’epoca (Lombroso, Garofalo, Ferri, Maino, Florian, Ottolenghi).
Matteotti, un anno dopo la pubblicazione di questa monografia, si occuperà ancora del tema, commentando una proposta di riforma per l’abolizione del domicilio coatto e l’introduzione della figura del recidivo abituale (Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen.).
Considerazioni critiche
Matteotti, non certo sordo alle esigenze di difesa sociale, è però ancorato a princìpi liberali della scuola classica e infatti afferma, criticando gli esponenti del positivismo, che "pena e reato soltanto sono due entità giuridiche; e non la temibilità sociale, sconosciuta al diritto”: in questo modo, mostrando di valutare prevalentemente le esigenze di sicurezza collettiva, pare evidente che “i positivisti si contraddicono ogni qualvolta mostrano di tenere anche conto dell'entità obiettiva del reato”.
Vengono così criticate le tendenze positivistiche a punire il reo non per il fatto commesso, ma per la sua pericolosità, in un'ottica di anteporre la difesa sociale ai diritti dell’individuo. In questo scontro, Matteotti però mantiene una posizione mediana, affermando che egli non vuole “soverchianti i diritti della società sull’individuo, ma nemmeno i diritti dell’individuo sulla società”. In questo passo, infatti - in cui tratta il tema della liberazione anticipata - egli afferma di ritenere ugualmente grave il male di una erronea liberazione e il male di una scarcerazione arbitrariamente rimandata: una parificazione che oggi difficilmente condivisibile.
Tuttavia, Matteotti si mantiene particolarmente scettico e critico nei confronti di Manzini e di quell’indirizzo da cui nascerà la scuola del tecnicismo: il giurista polesano aveva intuito che le costruzioni classiche erano utilizzate come “una vuota formula, atta a nascondere la disfatta del purismo giuridico di fronte alla necessità della difesa sociale”, avvertendo il rischio di una eccessiva e soverchiante valutazione delle istanze securitarie. Avverrà poi esattamente così, perché quelle elaborazioni teoriche saranno messe al servizio del potere punitivo fascista, sbilanciato verso la tutela della difesa sociale contro il diritto degli individui.
Merita poi un ulteriore approfondimento la tematica del “fattore personale permanente”, costruzione giuridica ideata dallo stesso Matteotti.
Con questa teorizzazione, il giovane penalista pare voler andare oltre l’annosa questione, delicata materia del contendere tra classici e positivisti, sulle cause del delitto. Egli vuole superare l’irrisolvibile e irrisolto scontro tra libero arbitrio e determinazione esterna (che sia sociale, oppure legata a fattori psichiatrici congeniti o ereditari). Matteotti sembra quasi non voler porsi il problema, o meglio, che ritenga questo interrogativo un ostacolo anziché una chiave di volta. Afferma che nel decidere se punire ci debba essere una coerenza, una coincidenza tra l'azione delittuosa e il fattore personale permanente, quale che sia la sua origine (genetica, ambientale, dipendente dalla sola volontà, ecc.). Ecco che il fattore personale permanente diviene causa individuale del crimine e la recidiva una "permanente tendenza antigiuridica” del reo.
In questo ragionamento potrebbe rilevarsi una prospettiva positivistica di partenza, ma certamente mitigata dall’idea che il delitto nasce da una disposizione intima del soggetto che si traduce poi nelle singole scelte criminose, al di là e oltre la singola occasione, in una visione non deterministica e quindi rispettosa dei postulati della scuola classica e liberale. Matteotti non è un eclettico perché non si sforza di fondere tutti gli inconciliabili postulati dei due schieramenti, ma in un qualche modo è in grado di costruire un sistema che, pur non negando critiche, anche dure, ad ogni scuola penalistica, immancabilmente deve importarne alcuni valori profondi, saldando insieme "determinismo (positivistico) e liberismo morale, senza rinunciare al ruolo centrale dell’elemento obbiettivo” [A. Gargani, Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo (a proposito degli Scritti giuridici di Giacomo Matteotti), in Quaderni fiorentini, XXXII, 2003, p. 565]. Egli infatti afferma che il fattore personale permanente può essere considerato dal determinista come “il carattere individuale risultante dall’eredità o dall'educazione", mentre dal liberista come una manifestazione della libertà di scelta. In ogni caso, per entrambi, i delinquenti sono “ugualmente responsabili e punibili, l’uno come unità sociale, l'altro come creatura umana”.
L’originalità del pensiero giuridico matteottiano è dunque rilevabile principalmente nel suo valorizzare in chiave progressista i fondamentali principi della scuola liberale [A. Gargani, Il sistema penale, cit., p. 558].
Per quanto riguarda invece l'approfondimento intorno alla pena indeterminata e al trattamento degli “incorreggibili”, vista la sostanziale identità di contenuti delle due opere, si rimanda alla scheda de Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen.
Influenza nelle opere successive e conclusione
Trattandosi della sua unica monografia, questo volume sulla recidiva è il contributo giuridico di Matteotti che certamente ha più lasciato il segno nella dottrina, venendo citato in moltissime opere successive durante gli anni.
Immediatamente dopo la pubblicazione, l’opera fu recensita su due autorevoli riviste [Redazione, in Il progresso del diritto criminale, anno II, settembre-ottobre 1910, pp. 325-326; A. Negri, Rendiconti analitici, in Rivista di diritto e procedura penale, Volume I, Parte I, 1910, pp. 440-445]. Entrambe le recensioni sono elogiative, pur contenendo alcune critiche sulla pena indeterminata e sulla eccessiva sommarietà con cui sono trattati certi temi. In particolare, per sottolineare ancora una volta l’indipendenza di pensiero di Matteotti, pare interessante riportare un passo della recensione comparsa sulla rivista Il progresso del diritto criminale: “Non è però un seguace, nel senso volgare della parola: tutt’altro. E certo spirito indipendente; sa mostrarsi acuto nel riesame e nella critica. Bisogna però che i giovani (non dispiaccia la parentisi) si guardino dal confondere l’indipendenza con una soverchia speditezza di conclusioni e di giudizio, con una specie di sentenziare che pare pretensioso e può essere anche leggiero. Il Matteotti è uno studioso serio, ma qualche volta ci è parso troppo sbrigativo”.
Certamente da segnalare, inoltre, che "l’approfondito studio” sulla recidiva è stato citato e valorizzato, soprattutto per i suoi dati statistici, anche in un rapporto del 1915 del dipartimento di Public Welfare della città di Chicago, testimonianza che lo scritto di Matteotti è stato letto e apprezzato anche oltre i confini nazionali [Chicago (Ill.) Department of Public Welfare, Semi-Annual Report, Vol. 1, 1915, pp. 95-96].
Qualche anno dopo, l’opera viene nuovamente citata [F. Grispigni, Introduzione alle sociologia criminale, Utet, 1928, pp. 95, 153, 155], per poi comparire in alcuni storici manuali di diritto penale sostanziale [A. Santoro, Manuale di diritto penale, Volume I, Utet, 1958, p. 286; G. Bettiol, Diritto penale (Parte generale), Priulla, 1966, p. 576; F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte generale, Giuffrè, 2003, p. 658].
Successivamente, il saggio è stato ripreso da diversi volumi che hanno trattato di recidiva [L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, 1989, p. 544; M. Sbriccoli, La penalistica civile, in Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, A. Schiavone (a cura di), Laterza, 1990, p. 208; E. M. Ambrosetti, Recidiva e recidivismo, Cedam, 1997, p. 239; G. Marra, Le modifiche apportate all'ordinamento penitenziario. Uno sguardo d'insieme, in A. Scalfati (a cura di), Nuove norme su prescrizione del reato e recidiva, Cedam, 2006, p. 301; V. B. Muscatiello, La recidiva, Giappichelli, 2008, pp. 15, 24, 28, 34, 37, 50, 65, 66, 87; M. Sbriccoli, Storia del diritto penale e della giustizia, scritti editi e inediti (1972-2007), Volume I, Giuffrè, 2009, p. 563; A. Manna, L. Lionetti, Le misure cautelari interdittive e reali per le persone giuridiche, in A. Manna (a cura di), Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro, Wolters Kluwer, 2023, p. 774; E. M. Mancuso, Il giudicato nel processo penale, Giuffrè, 2012, p. 126; F. Rocchi, La recidiva tra colpevolezza e pericolosità. Prospettive d’indagine nel sistema penale integrato, ESI, 2020, pp. 46, 205].
Allo stesso modo, la monografia è stata ampiamente citata dalla dottrina in contributi apparsi in diverse riviste [L. Mazza, voce Recidiva, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 1988, p 72; P. Pittaro, voce Recidiva, in Dig. disc. pen., XI, Torino, 1996, p. 360; L. Pellegrini, Recidiva e concorso omogeneo di circostanze ad effetto speciale - Il commento, in Diritto penale e processo, n. 11, 1 novembre 2011, p. 1366; R. Bartoli, Lettura funzionale e costituzionale della recidiva e problemi di razionalità del sistema, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.4, 2013, pag. 1701; D. Bianchi, Il fondamento della recidiva: ipotesi di razionalizzazione e ricadute applicative, in Diritto Penale e Processo, n. 9, 1 settembre 2014, p. 1118; A. Manna, Pericolo di reiterazione dei reati e recidiva “presunta”, tra persona fisica e giuridica, in Diritto di difesa, fasc. 2, 2022, p. 332; F. Diamanti, Nota a Corte Costituzionale, 11 luglio 2023, n.141, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 4, 2023, p. 1563].
Si segnala, infine, che il saggio di Matteotti è stato menzionato anche in una celebre opera di due importanti penalisti sudamericani [E. R. Zaffaroni, E. Oliveira, Criminology and Criminal Policy Movements, University Press of America, 2013, pp. 111, 127].
Al di là delle molte citazioni e riconoscimenti, anche recenti, questa monografia stupisce per il rigoroso metodo di raccolta di dati al servizio di un ragionamento che - pur presentando ampiamente le tesi della dottrina dell’epoca - è in grado di mantenere un punto di vista autenticamente libero e per nulla condiscendente nei confronti degli autori anche più influenti, consacrando l’opera come una lettura ancora fondamentale nell’ambito dello studio della recidiva, sia come fenomeno sociale di ricaduta nel reato, sia come istituto giuridico di diritto penale.
Le altre opere
Le altre schede
Riforme penitenziarie in Inghilterra - Il segreto delle confessioni in alcune legislazioni straniere - Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen. - Nullità assoluta della sentenza penale - Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare - Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale) - Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) - Classificazione degli incidenti di esecuzione - Rendiconti analitici - G. Sabatini: Principi di scienza del diritto penale. Catanzaro 1918, pag. 205 - Il pubblico ministero è parte