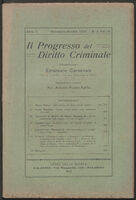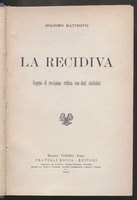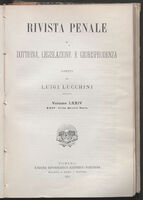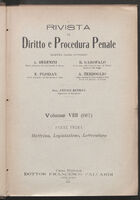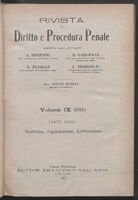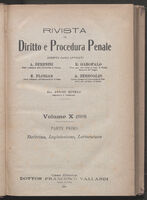Guida alla lettura - Riforme penitenziarie in Inghilterra
Autore: Giacomo Matteotti Opera: Riforme penitenziarie in Inghilterra In Il Progresso del Diritto Criminale, Settembre-Ottobre 1910, n. 5 - Vol. II, pp. 317-318 Diretta da Emanuele Carnevale Anno: 1910
Sintesi dell’opera.
In questo contributo della fine del 1910, l’allora venticinquenne Giacomo Matteotti valorizza un importante discorso di Winston Churchill, all’epoca Segretario di Stato per gli affari interni del Regno Unito, il quale, qualche mese prima, aveva presentato alla Camera dei Comuni un ambizioso progetto di riforma del sistema carcerario ispirato a princìpi di proporzionalità della pena e reintegrazione del reo in società.
Matteotti, fresco della pubblicazione della sua prima opera scientifica, la monografia sulla recidiva, analizza le proposte di Churchill e ne riconosce i molti meriti, non mancando di evidenziarne brevemente anche alcune criticità.
Il giurista polesano ripercorre i punti principali del discorso del Ministro inglese: un primo punto fermo e principio fondamentale, riporta Matteotti, è che la detenzione in carcere, seppur talvolta necessaria, è una sconfitta. Per questa ragione, il sistema deve essere costruito affinché il minor numero possibile di persone siano rinchiuse in prigione. Le motivazioni di ciò risiedono nel fatto che la detenzione è un male per il singolo individuo, che si vede privato della sua libertà, ma è anche una perdita per lo Stato dal punto di vista economico e sociale.
Un altro passaggio su cui si sofferma il Ministro inglese e riportato da Matteotti consiste nel riconoscere l’errore di incarcerare coloro che non possono permettersi di pagare le multe, anziché consentire versamenti rateali: così facendo, l’unica conseguenza è che “lo Stato perde i soldi, e la persona va in prigione, magari per la prima volta, un evento traumatizzante" [Tradotto da W. Churchill, Speech to the House of Commons, Hansard, 20 luglio 1910, c. 1352].
È poi citato positivamente l’istituto del Probation Act (condanna condizionale) e vengono considerate pregevoli le osservazioni sulla devianza giovanile.
Un tema appena accennato da Matteotti e presente nel discorso di Churchill è quello di sviluppare in modo significativo l’istruzione in carcere e lo svago musicale, programmi volti al recupero dei condannati che in effetti saranno implementati in Inghilterra nei decenni successivi [Si fa riferimento a lezioni serali con insegnanti professionisti nei penitenziari inglesi intorno agli anni ‘20 in A. Paterson, English prisons, in The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 157.1, 1931, p. 169].
Nell’ultima parte del resoconto viene considerata opportuna una riforma del sistema di liberazione condizionale, in vista di una deburocratizzazione che renda più efficace l’istituto.
Vengono poi sottolineate alcune ombre. Matteotti contesta i criteri di Churchill sulla segregazione cellulare, in quanto ritiene che talvolta possa essere utile per evitare il contatto tra i nuovi detenuti alla prima esperienza e i criminali recidivi già incarcerati.
Sono infine avanzati dubbi sulla proposta di rispondere alla devianza giovanile tramite “l’antico sistema della palla da cannone trascinata senza fine e senza scopo”: quegli spiacevoli e faticosi esercizi ginnici che secondo Churchill, evitando il danno del carcere per i ragazzi che non si erano macchiati di gravi delitti, avrebbero comunque rivestito una funzione deterrente.
Inquadramento e contestualizzazione nel panorama giuridico
La disciplina carceraria nell’Italia dell'epoca era normata dal Regolamento carcerario del 1 febbraio 1891, il quale, pur abolendo alcune pratiche disumane e favorendo l’integrazione di nuove discipline come la medicina e la psicologia nel trattamento dei detenuti, non portò a un reale miglioramento delle loro condizioni. Secondo la dottrina, le problematiche del sistema rimasero pressoché inalterate, anche a causa delle difficili condizioni in cui operavano gli agenti di custodia, mal addestrati, spesso in conflitto con i detenuti e costretti a ricorrere alla violenza come principale strumento di controllo [S. Torge, Il regolamento del 1891 e l’età giolittiana, in L. Pace, S. Santucci, G. Serges (a cura di), Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario, Aracne, Roma, 2011, pp. 16-19].
Nei decenni successivi non vi furono riforme di rilievo e il lavoro forzato continuava a rappresentare un pilastro fondamentale della pena. I pochi regi decreti emanati ebbero un impatto pratico piuttosto scarso, mentre numerose proposte riformatrici rimasero inascoltate. Filippo Turati, compagno di partito di Matteotti, espresse una delle più forti denunce della situazione nei penitenziari in un acceso discorso parlamentare. Il politico socialista accusò il sistema di violare la dignità del detenuto, al quale “si toglie il nome e il cognome, ogni senso della sua individualità, e sul camiciotto gli è cucito un numero, col quale sarà sempre chiamato, come ad ammonirlo che egli ha cessato di essere una persona, un individuo, un essere umano” [F. Turati, Dal Sepolcro dei vivi, in Discorsi parlamentari di Filippo Turati, Vol. I, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, p. 315].
Matteotti, in quegli anni, prestava una particolare attenzione alle tematiche legate alla reclusione, probabilmente a causa del suo interesse scientifico per la recidiva e per le sue idee politiche di socialista attento alla realtà carceraria. Ciò lo ha portato a interrogarsi sulla condizione nelle colonie penali – anche all’estero nei suoi periodi di permanenza fuori dall’Italia – che ritroviamo in altre sue opere di questi anni (Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen.).
Considerazioni critiche
Nella parte finale del contributo emerge un velo di amara ironia nelle parole di Matteotti, che, pur avendo come principale scopo quello di far conoscere in Italia i progetti d’oltremanica, non manca di accennare anche alla situazione nazionale.
Egli, infatti, elogia “l’opera affaticata di riforma sociale” attuata dal parlamento inglese, “a differenza dell’Italia, dove ormai forse tutte le nostre speranze sono costrette a rivolgersi piuttosto ai decreti reali”.
Matteotti, che da politico sarà uno dei più strenui e instancabili difensori delle prerogative parlamentari della storia italiana, in questo passo denuncia con disilluso sarcasmo l’immobilismo dei deputati e senatori del suo tempo. Si tratta, peraltro, di una questione persistente nella storia italiana, anche repubblicana: il problema della decretazione d’urgenza come surrogato dell’azione parlamentare rimane criticità discussa, attuale e sostanzialmente irrisolta fino ad oggi.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’ultima frase di questo breve contributo, in cui Matteotti sottolinea come lo spirito che anima le riforme del sistema carcerario in discussione in Inghilterra sia degno “di plauso e di studio”.
Questa espressione racchiude due livelli distinti: da un lato, il “plauso” si riferisce al riconoscimento dell’importanza di quei principi di umanizzazione della pena e reintegrazione sociale che ispirano le riforme britanniche; dall’altro, lo “studio” rimanda alla necessità di analizzarne attentamente le implicazioni concrete, affinché le riforme non restino semplici dichiarazioni di principio, ma si traducano poi in risultati effettivi.
Matteotti dimostra così la sua capacità di coniugare teoria e prassi, mantenendo sempre vivo il legame tra i princìpi e la loro effettiva applicazione, evitando il rischio che restino confinati in un dibattito puramente speculativo.
Influenza nelle opere successive e conclusione
I temi affrontati da Matteotti rimangono di grande attualità. Il principio secondo cui il carcere dovrebbe rappresentare l’extrema ratio nel sistema penale è un valore di primaria importanza per chi sostiene il diritto penale liberale. Anche le riflessioni sulla risocializzazione dei detenuti e sull'importanza di condizioni detentive dignitose trovano spazio nei dibattiti contemporanei, come dimostra l’importanza dell’art. 27 della Costituzione e dell'art. 3 della Corte europea dei diritti dell'uomo [si veda, ad esempio, Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia]. Il commento di Matteotti, dunque, pur riferendosi a una realtà specifica come quella inglese di inizio Novecento, affronta questioni ancora centrali nel dibattito sulla risposta punitiva.
Le altre opere
Le altre schede
La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici - Il segreto delle confessioni in alcune legislazioni straniere - Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen. - Nullità assoluta della sentenza penale - Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare - Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale) - Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) - Classificazione degli incidenti di esecuzione - Rendiconti analitici - G. Sabatini: Principi di scienza del diritto penale. Catanzaro 1918, pag. 205 - Il pubblico ministero è parte