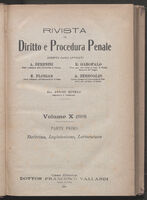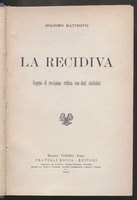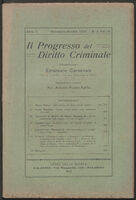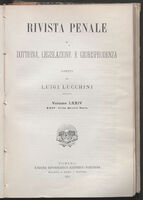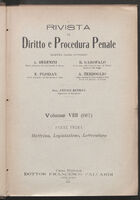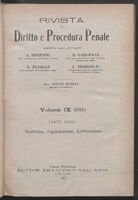Guida alla lettura - Rendiconto Sabatini
Autore: Giacomo Matteotti Opera: Rendiconti analitici - G. Sabatini: Principi di scienza del diritto penale. Catanzaro 1918, pag. 205 In Rivista di Diritto e Procedura Penale, Vol. X, Parte prima, pp. 154-156 Diretta da A. Berenini, R. Garofolo, E. Florian, A. Zerboglio Anno: 1919
Sintesi dell’opera
In questo breve resoconto, Matteotti recensisce il primo dei tre volumi che compongono l’opera di Guglielmo Sabatini sulla parte generale del diritto penale.
Sabatini, professore di diritto e procedura penale in diversi atenei italiani e direttore della rivista La scuola unitaria, era uno dei più importanti esponenti della “Terza Scuola”, fondata su teorie che puntavano a trovare una sintesi tra le posizioni della scuola classica e quelle della scuola positiva.
Nella prima parte di questa recensione, l’Autore analizza i principali temi trattati nel volume, ponendo l’accento sulla natura e finalità della norma penale, la funzione della pena e il concetto di imputabilità.
Matteotti ripercorre la struttura del volume, articolato nei seguenti capitoli: nel primo, Sabatini definisce l’ambito e i confini della scienza del diritto penale e sostiene il carattere unitario tra pene e misure di sicurezza, che devono entrambe discendere dalla commissione di un illecito; nel secondo individua come tratto distintivo del diritto penale il mezzo che utilizza, cioè la pena, la cui finalità principale è individuata nella special prevenzione; nel terzo, dopo alcune riflessioni sui criteri di interpretazione ed efficacia della legge penale nel tempo e nello spazio, si concentra sui soggetti protagonisti della scienza penale: lo Stato, che attua il dovere di punire, e l’individuo autore del reato. Matteotti indica, in questo terzo capitolo, la sezione dedicata all’imputabilità come la “più interessante parte del libro”.
Delineata questa panoramica generale, il giurista polesano entra poi nel vivo del dibattito tra le diverse scuole penalistiche dell’epoca ed emergono i giudizi più netti, in particolare nella sua decisa critica alla scuola del tecnicismo giuridico.
A partire dall’opera di Sabatini, Matteotti sviluppa una riflessione sulla natura della pena, con particolare attenzione alle tesi e argomentazioni della dottrina contemporanea. È in questo contesto che sottolinea il duplice scopo della pena, che comprende “il giusto e l’utile”, cioè l’emenda e l’eliminazione (funzioni che oggi chiameremmo special prevenzione positiva e negativa).
Matteotti esprime un “giudizio sintetico favorevole” sull’opera “nobilissima” di Sabatini, pur evidenziando la presenza di “incongruenze non rare”. Tali imperfezioni sono da ricondurre, secondo il penalista di Fratta, all’eclettismo del Professore, che non riesce a costruire un sistema del tutto coerente nel ricercare un punto d’incontro innestando elementi della scuola classica con quelli della scuola positiva.
La recensione si chiude con una riflessione sulla necessità di un dibattito dottrinale più organico per fondare su basi solide una nuova scienza del diritto penale.
Inquadramento e contestualizzazione nel panorama giuridico
In questa recensione Matteotti approfondisce in particolar modo alcuni aspetti centrali nel dibattito dottrinale dell’epoca, segnata da forti divisioni e tensioni tra le principali scuole.
L’Autore si rivolge prima di tutto agli esponenti della scuola classica, che accusa di aver rinunciato alla propria “migliore tradizione” per “impaludarsi nel tecnicismo giuridico”, definito come “commento inanimato del diritto vigente”.
Al contrario, sostiene Matteotti, i positivisti, avendo saputo distaccarsi dagli “errori dei precursori”, riescono ora maggiormente a riconoscere le caratteristiche del diritto penale “e quanto di buono vi hanno apportato la tradizione e l’esperienza storica”, unendo a ciò anche le “ultime conoscenze scientifiche”. Emerge, in questo passo, il lato di Matteotti più vicino alle istanze di una certa corrente della scuola positiva, sebbene egli non possa essere annoverato tra i positivisti e sarebbe un errore definirlo tale, nonostante gli importanti influssi derivanti dalla sua decennale esperienza politica e dalla sua militanza socialista.
Il Matteotti penalista si pone, in un certo senso, al contempo fuori e dentro al dibattito contemporaneo. La sua estrema intransigenza intellettuale e il rifiuto di accettare comodi compromessi gli consentono di mantenere una visione sempre lucida, personale e non acriticamente legata alle ideologie più in voga nella dottrina e nella società del tempo.
Per questa ragione non intende aderire in toto ad alcuna scuola e, in definitiva, sfugge a qualsiasi rigida categorizzazione: è legato e riconoscente al suo maestro Stoppato, ammira Lucchini, intrattiene rapporti di stima reciproca con Florian e recensisce positivamente quest’opera di Sabatini.
Considerazioni critiche
La parte del lavoro di Sabatini più apprezzata da Matteotti riguarda il problema dell’imputabilità e la responsabilità del reo. Secondo Sabatini, questa “è tanto maggiore quanto maggiore è la corrispondenza tra la natura della condotta” e la “personalità del soggetto”, che è legata alla “immanenza criminale”, cioè allo “stato di interiore disposizione a violare i precetti”. Questo concetto, in effetti, ricorda molto la tesi di Matteotti sul “fattore personale permanente” enunciata quasi dieci anni prima nella sua monografia La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici. Sabatini però, partendo da questa posizione condivisa da Matteotti, poi “ritorna ai vani tentativi degli eclettici" e, in particolare, richiama la formula della "identità individuale” di Gabriel Tarde.
Matteotti non condivide assolutamente questa impostazione, perché imporrebbe che ogni uomo agisca sempre in conformità ad una sua personalità cristallizzata. Mentre invece, afferma il giurista polesano, ogni individuo è al tempo stesso una moltitudine, un’evoluzione continua e non è mai uguale a sé stesso: risulta così velleitario il tentativo di definire una identità individuale immutabile che guiderebbe ogni scelta delle persone. Tale ricostruzione tenta di mediare tra l’esaltazione della libertà umana della scuola classica e il determinismo sociale di certa criminologia positivista, ma risulta, secondo Matteotti, artificiale e lontana dalla realtà.
In sintesi: sia Matteotti che Sabatini riconoscono che la personalità influisce sulla responsabilità dell’individuo, ma mentre Sabatini vede l’interiorità umana come tendenzialmente stabile e immutabile, Matteotti la considera dinamica, in continua evoluzione. Per questo, respinge l’idea di un’identità fissa che determina le condotte.
In un altro passaggio interessante, Matteotti nota una “felice contradizione” nel pensiero del Sabatini, che da un lato afferma che la scienza penale non deve occuparsi dell’indicazione dei reati, di competenza del legislatore, ma allo stesso tempo deplora l’abuso della pena per trasgressioni minime. In questo breve passo sono implicitamente richiamati due capisaldi del diritto penale liberale moderno: la tensione verso un diritto penale minimo e la valorizzazione del principio di offensività.
Ulteriore aspetto fondamentale affrontato da Matteotti riguarda la successione della legge penale nel tempo. Egli concorda con Sabatini sulla “non extrattività” della norma penale (che comprende la non retroattività e la non ultrattività), ma non condivide la motivazione, quasi tautologica, fornita dall’Autore. Secondo Matteotti, infatti, Sabatini “perde la più bella occasione per dimostrare il valore e la coerenza dei principii generali”, perché ritiene priva di una valida argomentazione logico-giuridica la volontà eclettica di unire il pensiero dei sostenitori della sola non retroattività, secondo i princìpi retributivi, a quello dei sostenitori della sola non ultrattività, secondo i princìpi positivistici.
Matteotti sostiene che esiste un’argomentazione in grado di illustrare in modo chiaro sia la regola della non retroattività che quella della non ultrattività: la pena deve essere al contempo giusta e utile. Giusta, perché deve essere quella prevista dalla legge al momento del reato; utile, perché deve continuare a essere considerata necessaria anche dalla legge successiva e vigente.
Influenza nelle opere successive e conclusione
La recensione di Giacomo Matteotti rappresenta un importante contributo al dibattito penalistico del primo Novecento e consente di meglio comprendere la posizione del giurista polesano nel panorama dottrinale dell’epoca.
Sabatini, negli anni successivi, non smetterà di sostenere posizioni eclettiche e proseguirà nel tentativo di unire elementi tradizionali della scuola classica, come il principio di legalità, con le innovazioni della criminologia positivista, come il sostegno per le misure di sicurezza, trovando la sintesi nel supporto alle politiche del regime fascista, evidenziato in modo eloquente nella sua prolusione del 1929 presso l’Università di Urbino [G. Sabatini, Le basi della nuova legislazione penale italiana. Discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico 1929-1930 pronunziato il giorno 11 novembre 1929, Urbino, 1930].
Le altre opere
Le altre schede
La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici - Riforme penitenziarie in Inghilterra - Il segreto delle confessioni in alcune legislazioni straniere - Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen. - Nullità assoluta della sentenza penale - Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare - Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale) - Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) - Classificazione degli incidenti di esecuzione - Il pubblico ministero è parte