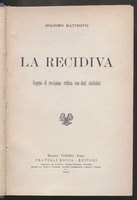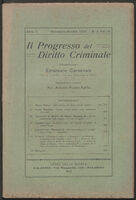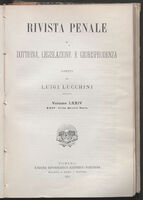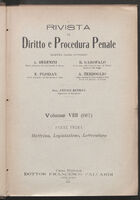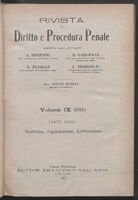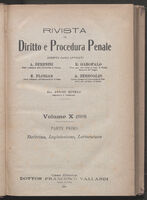Guida alla lettura - Progetto Luzzatti
Autore: Giacomo Matteotti Opera: Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen. In Rivista di Diritto e Procedura Penale, Vol. II - Fasc. IV, Parte prima, pp. 203-217 Diretta da E. Florian e A. Zerboglio Anno: 1911
Sintesi dell’opera
Il progetto Luzzatti (Disegno di legge n. 559 del 1910), commentato da Matteotti in quest’opera, era una proposta di riforma di alcuni articoli del codice penale in materia di domicilio coatto e di nuove misure contro i recidivi abituali e pericolosi, proposta dall’omonimo Presidente del Consiglio.
Il primo obiettivo del progetto era di eliminare dall’ordinamento il domicilio coatto, considerato un “provvedimento di polizia concordemente condannato dalla dottrina, dal Parlamento, dalla opinione pubblica, nonché dalla pratica” [L. Luzzatti, Relazione ministeriale, in Rivista di diritto e procedura penale, Volume II, Parte prima, 1911, p. 35].
Siccome la riforma, oltre ad occuparsi di domicilio coatto, dettava una nuova disciplina per i recidivi abituali, anche con l’introduzione della pena a tempo indeterminato, Matteotti la inquadra nel dibattito sulla repressione della criminalità abituale, un tema particolarmente discusso in quegli anni, nonché già affrontato nella sua monografia (La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici). Il penalista di Fratta, pur decidendo comunque di analizzarla nel dettaglio, mostra un certo scetticismo sulla reale attuabilità della riforma, sottolineando il rischio che possa non vedere la luce o, comunque, risultare inefficace. Tale rischio, in effetti, si rivelerà fondato, perché la caduta del governo Luzzatti impedirà al disegno di legge di essere approvato e di entrare in vigore.
Più in particolare, la proposta prevedeva un aggravamento delle pene per la recidiva (artt. 80-81 c.p.) e introduceva la figura del recidivo abituale, punito più severamente.
Dopo una panoramica sulla riforma, Matteotti analizza poi due esperienze estere che considera particolarmente significative in relazione alla recidiva e al trattamento carcerario.
In primo luogo accenna ad una legge inglese del 1908 che prevedeva per i recidivi abituali una “detenzione preventiva” tra i cinque e i dieci anni, ma che all’epoca era ancora in fase di sperimentazione e senza risultati concreti.
Successivamente, si dedica ad analizzare il funzionamento della colonia penale di Merxplas, in Belgio, un vasto complesso di detenzione e lavoro per mendicanti e vagabondi “inadatti alla onesta vita sociale”, descrivendolo con grande attenzione. Matteotti evidenzia i successi economici e organizzativi, ma anche i problemi “morali o sociali”, vero e proprio “punto nero di Merxplas”. Il tasso di recidiva, infatti, si attestava al 93%, rendendo chiaro che l’unico vero scopo perseguito con quella struttura non era “l’intimidazione, e tanto meno correzione”, ma soltanto “l’eliminazione, l’isolamento”.
Matteotti, tornando a riferirsi al panorama nazionale, lamenta che nemmeno questo scopo dell’eliminazione dei recidivi è del tutto perseguito, perché, come in Belgio, anche in Italia le pene sono troppo miti a causa della “mala tendenza indulgente dei nostri magistrati, favorita dai minimi e dagli infiniti ammenicoli attenuativi del codice”.
Il penalista di Fratta si schiera a favore di un trattamento duro dei recidivi e dunque vede con favore l’introduzione da parte della riforma della categoria dei recidivi abituali, evidenziando la “necessità che anche la nostra legge debba cominciare a conoscerli”. Il problema si sposta allora alla definizione di recidivo abituale, cioè sul numero di condanne necessarie per giungere a dichiarare tale status. Su questo aspetto si concentrano le critiche di Matteotti alla riforma, ritenuta troppo morbida. Egli infatti sostiene, richiamando i dati che aveva raccolto nella monografia sulla recidiva, che dopo il terzo delitto è quasi certo che il reo tornerà a delinquere.
Il giovane penalista si concentra poi sul tema della pena a tempo indeterminato per i recidivi abituali, dicendosi sostanzialmente favorevole, in un'ottica di determinazione della pena composta da un massimo individuato dal giudice, mitigata poi, durante l’esecuzione, dalla possibilità di liberazione anticipata da parte dell’amministrazione penitenziaria, nel suo ruolo di osservazione della personalità dei detenuti e della loro pericolosità.
Matteotti propone una differenziazione di regime detentivo per i diversi tipi di delinquenza, immaginando un trattamento quanto più individualizzato, ma sempre legato al lavoro, che all’epoca era obbligatorio. L’analisi procede con osservazioni sui vizi che caratterizzavano le colonie penali italiane, in cui sostiene che abbondassero “vino”, “scorpacciate” e “ozio”. Matteotti si oppone a tali degenerazioni, questo – afferma – “non per un inutile inasprimento di pena, cui siamo avversi, bensì perché crediamo assai pericolosa alla disciplina quella indulgenza generica, quel chiudere un occhio che si fa su certi atti solo nominalmente proibiti”. L’ultima parte è poi riservata al personale aggregato (medici, agronomi, cappellani, ecc.), considerato da rafforzare in numeri e qualità.
Inquadramento e contestualizzazione nel panorama giuridico
Come si accennava precedentemente, il Progetto Luzzatti naufragò senza avere alcuna conseguenza, travolto “dagli imminenti eventi bellici, segnando l’interruzione del lungo iter costellato di tentativi di riforme.” [A. Angrì, «Non è la morte il peggiore dei mali»: il domicilio coatto nell’Italia liberale, in Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna, 22/2022 - paper 19, p. 29].
Nella dottrina di quell’epoca, si deve rilevare anche il plauso di Garofalo e dei positivisti per il trattamento degli “incorreggibili” proposto dalla riforma. In tal senso, infatti, viene indicata come via maestra proprio la pena a tempo indeterminato, considerata “rimedio razionale e radicale contro i professionisti del delitto”, così che “saranno eliminati i delinquenti abituali” [R. Garofalo, L’abolizione del domicilio coatto e i provvedimenti contro i delinquenti abituali, in Rivista di diritto e procedura penale, II (1911), p. 67]. Sempre nel 1911, anche un altro importante esponente del positivismo si esprimeva sul progetto, lodandone le idee di partenza, ma criticando la non sufficiente durezza della risposta punitiva [E. Altavilla, I mezzi di difesa contro i recidivi abituali. A proposito del progetto Luzzatti, in Rivista di diritto e procedura penale, Volume II, Parte prima, 1911, p. 129].
Per quanto riguarda invece la colonia di Merxplas, negli anni successivi la dottrina positivistica si occuperà nuovamente di analizzarne pregi e difetti [Redazione, La “prigione-scuola” di Merxplas, nel Belgio, in La scuola positiva, Vol. IV, 1924, p. 120-121].
Considerazioni critiche
Il commento sul progetto Luzzatti si presenta come l’opera di Matteotti che pare risentire maggiormente dei segni del tempo. Certi spunti che fondono socialismo giuridico e positivismo sono, agli occhi dello studioso di oggi, difficilmente condivisibili, ma devono essere naturalmente contestualizzati nell’epoca in cui l’autore scrive.
In particolare, ci si riferisce ad alcuni passi relativi al trattamento auspicato per i cosiddetti delinquenti “inadatti alla onesta vita sociale”. Anche per i termini utilizzati, oggi risulta anacronistica la parte in cui vengono individuate come cause del delitto e della recidiva le “anomalie antropologiche, l’inferiorità psichica o morale, la condotta disonesta di vita, la repugnanza al lavoro, l'eredità, l’educazione e l'ambiente immorale”, sulla scia della criminologia di stampo positivistico dell’epoca.
In tema di pena indeterminata, Matteotti, di principio favorevole, propone un compromesso: istituire per i recidivi una “frequente e normale” relegazione per periodi molto lunghi in istituti di osservazione in cui raccogliere “notizie anamnestiche”, mediche e psichiche sui soggetti, con la liberazione anticipata come “ottimo mezzo a proteggere l'individuo dalle severità superflue di una sentenza frettolosa”.
Il problema principale, però, risiede nel potere che viene immaginato per “l’istituto d’osservazione, nel quale il condannato trascorre il primo periodo normale di pena”, che ha il compito di “vagliare e rettificare il giudizio” della sentenza di condanna.
Sorge allora, del tutto evidente, il tema della degiurisdizionalizzazione della pena, non più concretamente comminata dal giudice - che si limiterà ad indicare un massimo molto alto (fino a dieci o vent’anni) - al termine del processo, ma sostanzialmente determinata poi durante il trattamento dal “consiglio di sorveglianza”, organo di cui, secondo il giurista polesano, dovrebbe far parte chi “forse meglio di ogni altro conosce il detenuto” e, cioè, “il capoguardia”.
Evidente conseguenza di questa impostazione è lo spostamento della determinazione della pena da un giudizio basato sul diritto penale del fatto e sugli elementi oggettivi del reato ad un vaglio che tiene addirittura in considerazione come elementi decisivi il comportamento successivo, la personalità, la resipiscenza e la pericolosità del reo. In questo modo si entra in un’ottica che si allontana dalla tipicità e rischia di cadere nella valutazione sulle categorie di autori e di finire per penalizzare i soggetti più deboli dinanzi all’arbitrio di un potere non giurisdizionale e quindi quasi impossibile da sottoporre a controlli.
Risulta suggestiva ma altresì problematica anche l’ultima proposta avanzata in questo contributo, che suggerisce una diversificazione del trattamento carcerario a seconda del ‘tipo’ di delinquente, con la previsione di diversi istituti di detenzione con attività differenti per offrire un trattamento quanto più individualizzato possibile.
Se è certamente apprezzabile lo scopo di fondo di adeguare il trattamento penitenziario alle caratteristiche del reo, al fine di ottenere la più alta probabilità di recupero e risocializzazione, nell’ottica di una pena giusta e utile, è anche vero che tale progetto presenta anche una forte criticità.
Non viene affrontata la questione di chi debba effettivamente prendere le decisioni in merito all’assegnazione ai diversi istituti e ai relativi regimi detentivi, nonché ai criteri da adottare per distinguere i soggetti meritevoli di un trattamento più mite rispetto a quelli destinati a condizioni più afflittive. L’assenza di una chiara attribuzione del potere decisionale rischia di generare disparità di trattamento e di affidare tali scelte a organi amministrativi con ampio potere discrezionale.
In definitiva, la severità che pare trasparire dalle posizioni di Matteotti non è certamente fine a sé stessa, ma funzionale alla costruzione di un sistema punitivo che, nella sua impostazione socialista, intende il diritto penale anche come strumento di regolazione sociale. Questa tensione tra finalità rieducativa e rigore sanzionatorio rende l’intervento del giurista polesano interessante, ma al contempo problematico: se da un lato egli rifiuta l’idea di punire per punire, dall’altro, in questa fase giovanile, sembra accogliere un modello in cui la flessibilità della pena rischia di tradursi in una pericolosa discrezionalità, sottratta al controllo giurisdizionale.
Influenza nelle opere successive e conclusione
Dopo aver evidenziato tutte le criticità sopra menzionate, è bene però specificare che, per quanto riguarda la degiurisdizionalizzazione della pena, Matteotti svilupperà negli anni successivi una sensibilità diversa, probabilmente anche in seguito all’approfondimento del diritto processuale. In alcuni passi di opere più recenti (Classificazione degli incidenti di esecuzione e Dalla critica alla ricostruzione. A proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale), infatti, esprimerà il timore che la giurisdizione lasci il passo ad un potere amministrativo che utilizza strumenti sostanzialmente penali. La maturazione di pensiero pare completa quando, nel 1919, scriverà che affidare un provvedimento all’amministrazione “significa subito abbandono alla discrezione più indiscreta, all'arbitrio".
Un anno dopo la sua pubblicazione, questo contributo sul progetto Luzzatti è stato menzionato su una nota rivista, che ne ha sintetizzato così il contenuto: “Matteotti fa alcuni confronti con l’estero, e propone degli emendamenti, pur lodando senza riserve l’abolizione del domicilio coatto” [Redazione, in Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Volume LXXIII, 1911, p. 755, n. 320].
In seguito, è stato citato anche in una recente monografia [V. B. Muscatiello, La recidiva, Giappichelli, 2008, p. 34-36] ed è stata sottolineata la sua visione di considerare le misure di sicurezza strumenti del diritto penale e non, come invece sosteneva Arturo Rocco, atti amministrativi post delictum [F. Colao, Il ”dolente regno dello pene”. Storie della “varietà della idea fondamentale del giure punitivo” tra Ottocento e Novecento, in Materiali per una storia della cultura giuridica, Fascicolo 1, giugno 2010, pag. 154].
In seguito, è stato citato anche in una recente monografia [V. B. Muscatiello, La recidiva, Giappichelli, 2008, p. 34-36] ed è stata sottolineata la sua visione di considerare le misure di sicurezza strumenti del diritto penale e non, come invece sosteneva Arturo Rocco, atti amministrativi post delictum [F. Colao, Il ”dolente regno dello pene”. Storie della “varietà della idea fondamentale del giure punitivo” tra Ottocento e Novecento, in Materiali per una storia della cultura giuridica, Fascicolo 1, giugno 2010, pag. 154].
Le altre opere
Le altre schede
La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici - Riforme penitenziarie in Inghilterra - Il segreto delle confessioni in alcune legislazioni straniere - Nullità assoluta della sentenza penale - Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare - Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale) - Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) - Classificazione degli incidenti di esecuzione - Rendiconti analitici - G. Sabatini: Principi di scienza del diritto penale. Catanzaro 1918, pag. 205 - Il pubblico ministero è parte