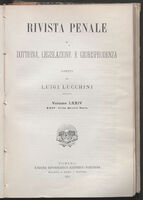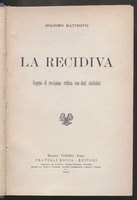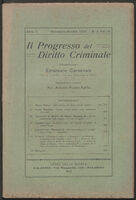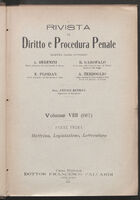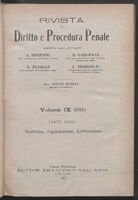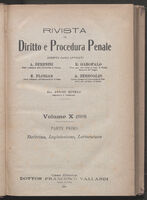Guida alla lettura - Il segreto delle confessioni
Autore: Giacomo Matteotti Opera: Il segreto delle confessioni in alcune legislazioni straniere In: Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Vol. LXXIV, pp. 589-590 Diretta da Luigi Lucchini Anno: 1911
Sintesi dell'opera
In questo contributo del 1911, Matteotti analizza il tema del segreto della confessione in diverse esperienze giuridiche europee, con particolare attenzione alla procedura penale tedesca. Il punto della questione è se i ministri del culto chiamati a testimoniare in un processo penale siano obbligati a rispondere a domande intorno a segreti appresi nell’esercizio della loro funzione, oppure se invece possano (o debbano) astenersi.
Il giurista sceglie di affrontare questo argomento perché in quel periodo - nella stampa italiana ed internazionale - era nato un acceso dibattito intorno al cosiddetto “caso Verdesi”: un procedimento penale nato dopo che un sacerdote si era confidato (non è chiaro se all’interno o all’esterno del sacramento della confessione) con un altro ecclesiastico, il quale aveva poi rivelato a terzi il contenuto del colloquio.
Matteotti concentra la sua analisi sulla Germania perché ritiene probabile che lì “la vivacità dei contrasti religiosi” abbia condotto alla migliore formula di legge.
Anzitutto, si sottolinea che il codice di procedura penale tedesco del 1877 non si limita a menzionare il sacramento cattolico della confessione, ma comprende tutte le confidenze ricevute da un ministro del culto nel contesto della cura delle anime.
Matteotti evidenzia che il diritto riconosciuto dalla legge al religioso non lo obbliga al silenzio, ma egli mantiene la facoltà di decidere se testimoniare o rifiutarsi. In ogni caso, il sacerdote non può essere costretto a testimoniare, nemmeno qualora il penitente lo svincoli dal segreto [In modo conforme, nella giurisprudenza italiana di quell’epoca, Tribunale di Roma 23 maggio 1911, Verdesi c. Bricarelli, in Rivista di Diritto e Procedura Penale, Volume II, 1911, p. 381].
Nella parte centrale del contributo, il giurista polesano fa riferimento ad alcune proposte avanzate dalla Reformkommission del 1904 per la riforma del codice di procedura penale tedesco, giunte in quel momento al vaglio di un'altra commissione del Reichstag, che aveva avviato le sue deliberazioni il 3 marzo 1910, per poi presentare il proprio rapporto al Parlamento il 16 gennaio 1911.
Alcuni membri avevano suggerito di estendere le garanzie del segreto confessionale, per rafforzare le tutele dei ministri di culto. La proposta principale era quella di proibire al giudice di interrogare i sacerdoti intorno a quanto appreso nel loro ministero di cura delle anime, impedendo dunque alla radice la formulazione di domande di tal genere. Altro elemento su cui la commissione si era trovata in accordo mirava a mitigare il divieto con l’ammissione dello svincolo dal segreto, peraltro consentito anche per la confessione secondo autorevoli teologi, ma non secondo la prassi consolidata e poi successivamente codificata dalla Chiesa cattolica [V., ora, Catechismo della Chiesa Cattolica, Parte II, Sezione II, art. 4, n. 1467].
Matteotti riporta sinteticamente le due principali obiezioni sollevate contro le proposte della commissione. La prima riguardava la difficoltà per il sacerdote di distinguere tra ciò che ha appreso nell’esercizio del ministero e ciò che, invece, ha conosciuto al di fuori di esso; la seconda ventilava il rischio che, con riserve mentali, l’ecclesiastico potesse negare ogni risposta. Matteotti dimostra l'inconsistenza di entrambe: la difficoltà nel distinguere i fatti conosciuti nell’esercizio della cura delle anime non sarebbe stata in alcun modo aggravata dalla riforma proposta e l’indiscriminata reticenza avrebbe continuato ad essere penalmente perseguita.
Nella parte finale del contributo viene menzionata la legislazione austriaca, che imponeva un divieto assoluto di testimonianza sugli atti appresi in confessione (con maggiore elasticità sulle altre confidenze); viene evidenziata poi la minor tutela del segreto nel sistema inglese e, invece, una maggiore garanzia nella prassi scozzese e irlandese.
Inquadramento e contestualizzazione nel panorama giuridico
È interessante notare che in Italia, nel codice di procedura penale Zanardelli (1865), ancora vigente all'epoca in cui Matteotti scrisse questo contributo, il segreto della confessione non era espressamente nominato. L’art. 288 del codice, infatti, disciplinava il segreto professionale come divieto dell’obbligo di deporre sopra i fatti conosciuti “in seguito a rivelazione o confidenza [...] nell’esercizio del proprio ministero” per alcune categorie: avvocati, medici, speziali e levatrici.
Al fianco di questa elencazione, era inoltre prevista una clausola di chiusura che comprendeva “ogni altra persona, a cui per ragione del suo stato e della sua professione od officio fu fatta confidenza di qualche segreto”. I ministri di culto risultavano inquadrabili in quest’ultima categoria, come peraltro emerge dalla dottrina del tempo [cfr. P.S. Mancini, Intorno al segreto professionale degli avvocati, pubblicato postumo in Indice Penale, 1988, 1, p. 11; E. Florian, La liberazione dall’obbligo del segreto, da parte dell’affidante, ed i suoi effetti processuali, in Rivista di Diritto e Procedura Penale, Volume II, 1911, p. 382].
Di ciò troviamo conferma anche nella giurisprudenza: proprio dalla sentenza del “caso Verdesi” [A. Roma, 11 agosto 1911, Verdesi c. Bricarelli, C.U. XXIV, 533] si può ricavare la massima secondo cui “il segreto confessionale è tutelato nell’art. 288 cod. proc. penale, e quindi il sacerdote non può essere obbligato a deporre sui fatti, venuti a sua cognizione in confessione, neppure col consenso del penitente” [Massima contenuta in Rivista Penale, Anno XXXVIII, Vol. 75-76, 1912, p. 698, n. 2].
Nella dottrina vi erano poi voci dissonanti sulla svincolabilità dei segreti con il consenso del confidente [Fortemente contrario G. Leto, Il segreto professionale secondo i principî e le leggi di procedura penale, in Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Volume LXXIX, 1914, p. 321; favorevole invece, eccetto per l’avvocato, E. Pessina, Elementi di diritto penale, Vol. II, 1883, p. 148].
In quegli anni, comunque, erano note le proposte per il nuovo codice che vedrà la luce nel 1913, in cui la materia sarà normata, con un impianto molto simile alle legge precedente, dall’art. 248. La novità del codice Finocchiaro-Aprile risiede nel fatto che “i ministri di un culto ammesso nello stato” sono nominati in modo specifico, così da eliminare ogni incertezza anche nel testo codicistico su un’interpretazione che era in ogni caso da considerarsi già pacifica nella dottrina e giurisprudenza antecedente.
Considerazioni critiche
Una particolarità di questo contributo è certamente che Matteotti si occupa di questioni processuali, mentre in quell’epoca il suo interesse era rivolto soprattutto al diritto sostanziale e, in particolare, ai temi del carcere e della recidiva.
Questo contributo rappresenta perciò un’eccezione nella sua produzione scientifica, o - più correttamente - un’anticipazione della fase successiva (‘17-‘19), in cui si dedicherà ad approfondire questioni profondamente tecniche della procedura penale (Nullità assoluta della sentenza penale; Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare; Classificazione degli incidenti di esecuzione; Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie).
La sezione più significativa dell’opera è quella in cui Matteotti commenta e valuta la proposta avanzata dalla Reformkommission tedesca di vietare al giudice di interrogare i sacerdoti su quanto appreso “sotto il sigillo della confessione". Il giurista polesano coglie con finezza un nodo centrale della questione: l’eventuale rifiuto del sacerdote di rispondere ad una specifica domanda potrebbe - nella prassi - essere “facilmente interpretato già come un’ammissione che l’imputato abbia realmente fatta una confessione religiosa in proposito, e quindi come un indizio a suo sfavore”.
Questa osservazione è particolarmente acuta, poiché mette in luce una tensione tra la tutela del segreto confessionale (ma anche professionale) e le dinamiche probatorie, centrando il cuore del problema. Matteotti evidenzia una potenziale criticità pratica che, sebbene non abbia trovato amplissimo riscontro nella dottrina italiana successiva, rimane una questione di non trascurabile rilievo.
Un'intuizione simile si ritrova, qualche anno dopo, in Gaetano Leto, il quale, lamentando il poco coraggio della riforma del codice del 1913, che a suo avviso non tutela sufficientemente i segreti, sottolinea una problematica della legislazione nipponica. In Giappone, infatti, era imposto, a coloro che opponevano un segreto per esimersi dal deporre intorno a determinati fatti, di rendere chiari e credibili motivi del rifiuto. Ciò, però, significherebbe “dimostrare che si tratta di un segreto professionale, e per ciò stesso rivelarlo col palesare i fatti, ai quali esso si riferisce” [G. Leto, Il segreto professionale, cit., p. 326]. Si tratta, a ben vedere, di una preoccupazione analoga a quella di Matteotti nel temere che le domande del giudice intorno al rifiuto di deporre finiscano esse stesse per rivelare che il segreto effettivamente esiste e, quindi, anche solo parzialmente, il suo contenuto.
Influenza nelle opere successive e conclusione
I codici successivi (Rocco del 1930 e Vassalli del 1989), pur con qualche differenza semantica, non hanno modificato in modo significativo la disciplina del segreto confessionale e professionale.
C’è poi da sottolineare che l’art. 7 dei Patti Lateranensi (1929) stabiliva il divieto di testimonianza e il divieto di porre domande su quanto appreso dal sacerdote nell'esercizio della sua funzione, in contrasto con quanto invece previsto dalla legge processuale, che riconosceva soltanto il diritto di non rispondere. Con l’Accordo del 1984 venne meno l’antinomia tra legislazione statale e Concordato, perché anche esso, da allora, prevede per gli ecclesiastici “un semplice esonero dall'obbligo” di testimoniare in merito a tali fatti [M. Chiavario, Confessioni religiose e processo penale: ulteriori appunti per un raffronto tra il codice Rocco e il codice vigente, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, fasc. 3, 2011, pag. 888].
In definitiva, questo contributo di Giacomo Matteotti si distingue per la lucidità dell’analisi e per la capacità di cogliere le implicazioni pratiche del segreto confessionale nel processo penale, offrendo una riflessione che ha il merito di tenere in considerazione diverse esperienze giuridiche europee.
C’è poi da sottolineare che l’art. 7 dei Patti Lateranensi (1929) stabiliva il divieto di testimonianza e il divieto di porre domande su quanto appreso dal sacerdote nell'esercizio della sua funzione, in contrasto con quanto invece previsto dalla legge processuale, che riconosceva soltanto il diritto di non rispondere. Con l’Accordo del 1984 venne meno l’antinomia tra legislazione statale e Concordato, perché anche esso, da allora, prevede per gli ecclesiastici “un semplice esonero dall'obbligo” di testimoniare in merito a tali fatti [M. Chiavario, Confessioni religiose e processo penale: ulteriori appunti per un raffronto tra il codice Rocco e il codice vigente, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, fasc. 3, 2011, pag. 888].
In definitiva, questo contributo di Giacomo Matteotti si distingue per la lucidità dell’analisi e per la capacità di cogliere le implicazioni pratiche del segreto confessionale nel processo penale, offrendo una riflessione che ha il merito di tenere in considerazione diverse esperienze giuridiche europee.
Le altre opere
Le altre schede
La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici - Riforme penitenziarie in Inghilterra - Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen. - Nullità assoluta della sentenza penale - Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare - Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale) - Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) - Classificazione degli incidenti di esecuzione - Rendiconti analitici - G. Sabatini: Principi di scienza del diritto penale. Catanzaro 1918, pag. 205 - Il pubblico ministero è parte