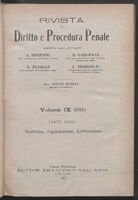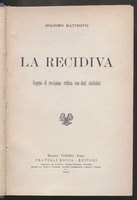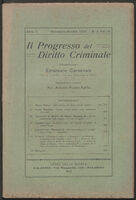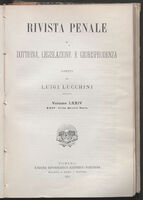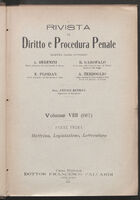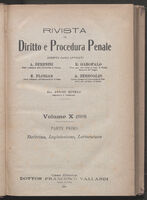Guida alla lettura - Dalla critica alla ricostruzione
Autore: Giacomo Matteotti Opera: Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale). In Rivista di Diritto e Procedura Penale, Vol. IX, Parte prima, pp. 396-398 Diretta da A. Berenini, R. Garofalo, E. Florian, A. Zerboglio Anno: 1918
Sintesi dell’opera
Questa breve lettera, inviata da Giacomo Matteotti nel 1918 al professor Eugenio Florian, si inserisce nel dibattito sulla giurisdizione dell’intendente di finanza, istituita dai decreti luogotenenziali sui consumi. Prendendo spunto da un articolo dello stesso Florian sull’argomento, Matteotti coglie l’occasione per sollevare questioni di più ampio respiro, che toccano il cuore del diritto penale sostanziale e processuale.
Il tema di partenza è la scelta legislativa di attribuire funzioni de facto giurisdizionali a un’autorità amministrativa come l’intendente di finanza. Matteotti, pur riconoscendo le incoerenze normative della disciplina, di per sé ambigua sul reale “carattere penale” della sanzione irrogata dall’intendente, non si limita alla critica, ma coglie l’opportunità per suggerire una ridefinizione dei confini della disciplina penale. Secondo il giurista polesano, infatti, il problema principale è da rilevarsi nell’eccesso di norme sanzionatorie che poco o nulla hanno a che fare con la reale essenza e scopo del diritto penale. La soluzione proposta è allora quella di depenalizzare buona parte delle contravvenzioni, relegandole nell’ambito del diritto amministrativo.
Nella seconda parte della lettera, Matteotti critica apertamente la tendenza ad attribuire una qualificazione penale a condotte di natura puramente formale, come la mancata apposizione di bolli o il mancato pagamento di tasse, che vengono punite in modo meccanico, senza alcuna valutazione sull’elemento soggettivo. Questo, a suo avviso, snatura il diritto penale, che dovrebbe invece mantenere una funzione selettiva e concentrarsi su reati dotati di reale offensività, tenendo sempre in considerazione la colpevolezza dell’autore.
Chiudendo la lettera, Matteotti, con un filo di amara ironia, si rammarica del fatto che i giovani giuristi trovino difficoltà a proporre riforme di grande respiro, a meno che non scrivano "grossi volumi infarciti di citazioni".
In calce alla lettera, vi è la risposta del Professor Florian, che elogia l'intervento dell’ “egregio nostro amico e collaboratore dottor Giacomo Matteotti”.
Egli riconosce il valore della proposta del penalista di Fratta, sottolineando la necessità che la materia penale sia “purificata dalle scorie”, cioè tutte quelle fattispecie che ne sbiadiscono i contorni, portando a una sua indebita espansione. Florian lega questa riflessione alle teorie della scuola positiva, che già in precedenza aveva messo in discussione l’eccessiva ampiezza della sfera penale, ritenendo che questa lotta alla "pseudo-delinquenza, delinquenza più di nome che di fatto” non giovi alla causa della repressione della criminalità reale e più pericolosa .
Inquadramento e contestualizzazione nel panorama giuridico
Come indicato dallo stesso autore, questa lettera prende spunto dalla critica di Florian alle prerogative dell’intendente della guardia di finanza, previste da una serie di decreti luogotenenziali varati durante la prima guerra mondiale [E. Florian, La giustizia penale dei “pieni poteri”, in Rivista di diritto e procedura penale, Volume IX, Parte prima, 1918, pp. 169-170].
In quel contributo, Florian contesta l'attribuzione di funzioni giurisdizionali all'intendente di finanza, evidenziando come questa figura sia stata resa un vero e proprio giudice penale per specifiche contravvenzioni. Il professore delinea la normativa: tale competenza è stata introdotta con il D.Lgt. 19 ottobre 1916, n. 1390 e successivamente rafforzata da altre norme, tra cui il D.Lgt. 6 maggio 1917, n. 740, che ha reso esclusiva la competenza dell'intendente per le sanzioni pecuniarie sulle trasgressioni ai regolamenti sui consumi.
Florian menziona anche altre estensioni del potere sanzionatorio dell’ufficiale di finanza, come nel caso delle infrazioni riguardanti l’abbattimento degli ulivi (D.Lgt. 21 febbraio 1918, n. 360 e D.Lgt. 18 aprile 1918, n. 497). L’autore, in verità non particolarmente preoccupato per la “creazione d’un nuovo organo speciale di giurisdizione punitiva”, mette in dubbio sia la sua coerenza con il sistema giuridico esistente sia la sua efficacia, arrivando a concludere che si tratta più di un’improvvisazione legislativa che di una riforma ideata con una logica sistematica.
Ciò, in effetti, emerge anche nella risposta di Florian alla lettera di Matteotti, dalla quale pare che la preoccupazione principale del professore positivista riguardi non tanto la salvaguardia del principio di riserva di giurisdizione in materia penale, quanto più il rischio di un ‘annacquamento’ del diritto penale con conseguente indebolimento della risposta punitiva.
Considerazioni critiche
In questa - pur breve - lettera, Matteotti è in grado di far emergere temi di importanza capitale. Si esprime esplicitamente nel denunciare “lo scandalo giuridico di un intendente di finanza che siede a giudicare reati e delinquenti”, ipotesi “grave assai, grave in procedura e grave in diritto”. Si manifesta, così, in modo netto la critica alla amministrativizzazione della giustizia penale, alla inaccettabile commistione tra potere esecutivo e giudiziario.
Le sue osservazioni si spostano poi a contestare anche “il pretore che giudica per decreto”. In questo caso, il problema non riguarda più il soggetto che irroga la sanzione penale, quanto piuttosto le modalità: le pene sono “proporzionate a chilogrammi di prosciutto” e “applicate ai più diversi individui, senza conoscerli, senza sentirli”. Con questa metafora, la denuncia di Matteotti si fa vibrante, accostando il giudizio penale ad una fabbrica di condanne standardizzate, senza alcuna attenzione al caso concreto, all’approfondimento e alla reale cognizione degli elementi oggettivi e soggettivi.
Influenza nelle opere successive e conclusione
Pur non avendo avuto, come si può immaginare, particolare seguito, questa lettera si distingue in particolare per un’intuizione estremamente moderna ed attuale, in tema di depenalizzazione ed eliminazione della categoria delle contravvenzioni. Matteotti auspica che sia espunta “finalmente dal diritto penale tutta codesta materia che non gli appartiene, che anzi lo deforma [...] e cioè la grande massa delle infrazioni che vanno giudicate per sé stesse, nella loro pura obbiettività materiale, all’infuori di qualsiasi considerazione dell’agente e dell’elemento morale”.
Il penalista polesano propone così di far arretrare il diritto penale, augurandosi che divenga davvero extrema ratio, delegando ad altre discipline il compito di occuparsi di quelle violazioni che non presentano soglie di offensività e di disvalore tale da richiedere l’impiego dello strumento repressivo.
Le parole di questa lettera di Matteotti sul processo come luogo della condanna senza adeguato approfondimento costituiscono una lezione che dovrebbe essere ascoltata anche oggi, dal momento che si assiste ad una sempre più pressante fuga dal dibattimento, spesso non per una reale volontà dell’imputato, ma per volontà della stessa legge che incoraggia in tal senso, o talvolta per ‘suggerimento’ – anche poco discreto – della magistratura.
Le altre opere
Le altre schede
La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici - Riforme penitenziarie in Inghilterra - Il segreto delle confessioni in alcune legislazioni straniere - Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen. - Nullità assoluta della sentenza penale - Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare - Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) - Classificazione degli incidenti di esecuzione - Rendiconti analitici - G. Sabatini: Principi di scienza del diritto penale. Catanzaro 1918, pag. 205 - Il pubblico ministero è parte