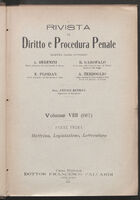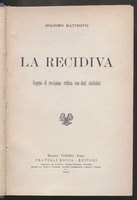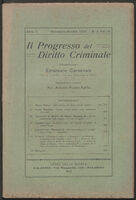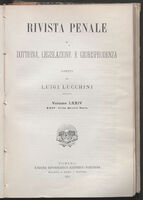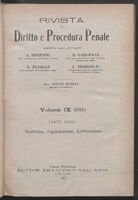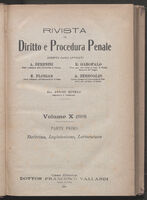Guida alla lettura - Nullità assoluta della sentenza penale
Autore: Giacomo Matteotti Opera: Nullità assoluta della sentenza penale In Rivista di Diritto e Procedura Penale, Vol. VIII, Parte prima, pp. 315-343 Diretta da A. Berenini, R. Garofalo, E. Florian, A. Zerboglio Anno: 1917
Sintesi dell’opera
In questo contributo Matteotti analizza in modo puntuale ed approfondito la categoria della nullità nel processo penale. Il giurista polesano non ha timore nel criticare, anche aspramente, “alcuni dei migliori cultori” del diritto processuale, al fine di difendere il principio di legalità processuale, punto di partenza imprescindibile per ogni considerazione intorno all’interpretazione della norma.
Il primo problema affrontato in tema di nullità è quello, centrale, della chiarezza terminologica, sia nel codice che nei commenti degli autori: secondo Matteotti, infatti, “la parola nullità ha ormai assunti significati troppo vicini e troppo differenti nel tempo stesso”.
Un aspetto fondamentale che viene evidenziato è la differenza tra nullità assoluta e inesistenza della sentenza: al centro di questa distinzione, infatti, sta l’intangibilità del giudicato. Proprio in netta contrapposizione a quelle ambiguità terminologiche e di vedute, Matteotti prende posizione in modo esplicito sulla rilevabilità ultra iudicatum delle nullità: “Sono le nullità [...] rilevabili in sede di esecuzione? E rispondiamo subito: no, assolutamente.” Egli dunque ritiene che, divenuta definitiva la sentenza, non sia più consentito dolersi di nullità occorse durante il procedimento.
Matteotti ammette l’esistenza di una certa ambiguità terminologica del codice, ma sostiene che in realtà è chiara “la volontà del legislatore” nell'individuare il limite del giudicato per sollevare la doglianza: se invece le nullità fossero sempre rilevabili, non avrebbe senso prevedere per la loro rilevazione l’impugnazione in appello e in cassazione, ma sarebbero tutte dedotte in sede esecutiva.
Matteotti esamina poi, confutandole, alcune ricostruzioni di importanti esponenti della dottrina dell’epoca, concentrandosi in particolare sul pensiero di Vincenzo Lanza, il quale invece riteneva le nullità assolute sempre rilevabili, anche in executivis.
Il giurista polesano non nega il valore e l’importanza del perseguimento di una giustizia sostanziale, apparentemente negata nell'impossibilità di eliminare gli effetti di una sentenza viziata da gravi patologie, ma rimarca che il dovere dello studioso sia quello di valutare ed interpretare le norme nel rispetto del testo di legge, perché “gli inconvenienti non si tolgono con sottigliezze e amputazioni incoerenti”. È infatti preferibile che sia la pratica a mettere in evidenza tali problematiche per poi poter “suggerire oneste e sicure modificazioni” della legge.
Matteotti procede con l’analisi concentrando l’attenzione sulla categoria della inesistenza della sentenza, quella sì rilevabile anche in sede esecutiva. In questa parte, egli critica una certa abitudine dei processualpenalisti dell’epoca di cercare conferme delle proprie costruzioni sulla scorta della dottrina tedesca e della traslazione di istituti di diritto processuale civile, non considerando le profonde ed ineliminabili differenze tra le due discipline. Anche da qui deriverebbero quelle ambiguità che consentono di interpretare la nullità assoluta alla stregua dell’inesistenza.
Nella parte centrale del contributo, Matteotti propone una casistica concreta esemplificativa, tornando a definire l’inesistenza con caratteri estremamente restrittivi: l’unica sentenza inesistente è quella pronunciata da “chi non è giudice”. Esamina inoltre i casi di pena illegale o impossibile e di sentenze prive di dispositivo o di motivazione, concludendo che, pur trattandosi di vizi gravi, tali pronunce devono comunque ritenersi esistenti, sebbene viziate.
Ciò che riesce a cogliere, anticipando anche la più moderna dottrina sul punto, è che l’esistenza della sentenza è “un fatto e non una questione di diritto”, evidenziando il paradosso che “non si può impugnare ciò che non esiste”.
Davanti al giudice di esecuzione sarà dunque inutile dedurre difetti giuridici della sentenza, per quanto gravi, perché la cosa giudicata gli vieta di esaminare eccezioni giuridiche. Solo un fatto, cioè la radicale inesistenza della sentenza, potrà invece rilevare ed essere eccepito. Soltanto in quel caso il giudice, riconoscendo la non esistenza di una sentenza, non potrà conseguentemente ordinarne l’esecuzione.
Matteotti conclude l’opera con una panoramica riassuntiva distinguendo tra nullità relative, assolute e inesistenza. Infine ribadisce nuovamente il concetto del necessario rispetto della legalità processuale: “questa è la legge che ne governa, questo, credo, il diritto che si deve applicare secondo il codice vigente [...]. Si applichi quello che la legge vuole”.
Inquadramento e contestualizzazione nel panorama giuridico
La normativa di riferimento è il codice Finocchiaro-Aprile del 1913, in cui le nullità sono disciplinate negli artt. 135 e seguenti. In particolare, l’art. 136 tratta della nullità assoluta, che “non può essere sanata in alcun modo” e “può essere dedotta in ogni stato e grado del procedimento e deve anche essere pronunciata di ufficio”.
L’inesistenza, invece, è una categoria di vizio mai prevista espressamente dalla legge, ma soltanto teorizzata da dottrina e giurisprudenza per individuare i casi in cui una sentenza è priva degli elementi essenziali per essere definita tale, e dunque non può produrre alcun effetto giuridico [Un esempio dell’epoca riguarda una sentenza pronunciata in udienza ma non redatta per iscritto né firmata, considerata inesistente dalla Cassazione. Cass. 18 gennaio 1910, in Rivista di diritto e procedura penale, I, Parte seconda, 1910, p. 195, con nota critica di E. Florian, Sulla pretesa inesistenza delle sentenze penali pronunciate e non firmate per effetto del disastro di Calabria e Messina].
In questo contesto, dopo una breve critica alle costruzioni di Escobedo e Stoppato sul momento in cui la sentenza diventa irrevocabile, l’attenzione di Matteotti si concentra sulle tesi, nettamente minoritarie in dottrina, di Vincenzo Lanza. Quest’ultimo, tramite un’interpretazione che si avventurava oltre la lettera della legge, sosteneva l’estensione degli effetti della nullità assoluta della sentenza, consentendo che tale vizio potesse essere dedotto anche in sede di esecuzione e dopo la formazione del giudicato, al pari dell’inesistenza [cfr., con sfumature leggermente diverse, V. Lanza, Principi di diritto processuale penale, Athenaeum, 1914, pp. 122-123; V. Lanza, Azione esecutiva come azione revocatoria - Saggio sui poteri del giudice di esecuzione, in Rivista Penale, gennaio-febbraio 1916, p. 5].
Si tratta di una posizione, scrive il giurista polesano, in cui “la deviazione dal concetto del legislatore è evidente” e che, dunque, “deve essere subito combattuta anziché favorita”.
Parimenti critico nei confronti di Lanza in quegli anni è Santoro, che, come Matteotti, considera tali tesi “completamente al difuori del diritto positivo”, perché contrarie alla “esigenza giuridica del rispetto al giudicato” e al “concetto di nullità, che non può agire al di fuori del processo di cognizione” [A. Santoro, Sunti di articoli, recensioni e rassegne complessive, in La Scuola positiva, Anno XXVI, 1916, p. 240].
Un altro aspetto di fondamentale importanza in questo contributo è la critica di Matteotti alla cosiddetta penalistica civile, una teoria - particolarmente diffusa in quell’epoca tra chi si occupava di diritto e procedura penale - che consisteva nel fondare istituiti penalistici su categorie concettuali del diritto civile. In questo contesto, il penalista di Fratta critica la dogmatica della nullità di quella dottrina che argomentava le proprie posizioni poggiandosi sulla procedura civile tedesca, in particolare sulla visione del processo come “serie di negozi giuridici”. Matteotti mette in guardia da questo metodo, rivendicando l’indipendenza e la peculiarità del processo penale: “la teoria del negozio giuridico [...] non ci sembra applicabile per semplice trasposizione alla procedura penale”; farlo costituirebbe un “errore storico profondo” e “il principio stesso è abbastanza discutibile”.
Considerazioni critiche
Questo contributo sulla nullità si presenta come il più importante e illuminato intervento di Matteotti in tema di procedura penale.
Risulta, anzitutto, di particolare valore la ricostruzione della categoria dell’inesistenza. Il giurista polesano ammette l’impossibilità di disciplinare nel codice tale patologia perché "ciò che non esiste mal si presta ad essere descritto”; l’unica soluzione sarà dunque che la dottrina ne discuta e che la pratica giudiziaria la riconosca, in modo da negare efficacia giuridica ai provvedimenti viziati in tal modo.
Proprio però per l’impossibilità di cristallizzare una definizione di inesistenza nel diritto positivo, Matteotti aderisce ad un'interpretazione estremamente restrittiva nel circoscriverne i confini: la non esistenza dovrà limitarsi a sentenze mai emanate o mancanti degli “elementi essenziali”. La questione centrale si sposta allora sul valutare quali siano questi “elementi essenziali” che, se mancanti, non consentono alla sentenza di esistere.
Matteotti, dopo aver esaminato un’ampia casistica, afferma che a non esistere è soltanto la sentenza emanata da chi non è giudice, da chi è privo di giurisdizione. Esclude dal novero dell’inesistenza, invece, casi gravissimi come le ipotesi di giudici vittime di costrizione morale o materiale o incapaci nel momento della pronuncia. Allo stesso modo, ritiene certamente nulle ma esistenti sentenze prive di dispositivo, con dispositivo contraddittorio o di condanna a pena impossibile o equivoca (ad es., “diecimila lire di carcere”). Se una sentenza viziata in tal modo non venisse impugnata e, passata in giudicato, diventasse definitiva, Matteotti ritiene che il giudice dell’esecuzione dovrebbe comunque darvi seguito, interpretandola “secondo logica e secondo legge".
Questa soluzione, però, non pare del tutto convincente. Nei casi di mancanza di dispositivo o di dispositivo contraddittorio l’interpretazione sarebbe soltanto un’apparenza, nascondendo, in realtà, una vera e propria decisione sul merito della questione, sulla innocenza o colpevolezza: una decisione, dunque, legata al merito del processo, ambito estraneo al giudice dell’esecuzione.
In definitiva, pare che nella pur comprensibile motivazione di voler ridurre al minimo i casi di inesistenza della sentenza, Matteotti sia arrivato al punto di attribuire al giudice dell’esecuzione delle prerogative che non può avere: i casi di mancanza di dispositivo o di dispositivo totalmente contraddittorio – così come i casi di pena indeterminata, illegale o impossibile – dovrebbero essere inquadrati nell’inesistenza della sentenza.
Trattando il tema dell’inesistenza, si segnala anche che Matteotti pare intuire, seppure in modo ancora embrionale, alcuni tratti che caratterizzeranno poi la dottrina in tema di abnormità con diversi anni di anticipo rispetto alle prime teorizzazioni di Aloisi degli anni ‘30 [qualche anno dopo rappresentate in U. Aloisi, Manuale pratico di procedura penale, Volume III, Delle Impugnazioni, Milano, Giuffrè, 1952, p. 47]. È interessante perché, come per l’inesistenza, anche l’abnormità costituisce un vizio che il legislatore ha deciso di non codificare ma che viene rilevato di volta in volta dalla giurisprudenza. Il penalista di Fratta fa riferimento ai casi di “sentenza non impugnabile gravemente viziata di fronte al diritto” o di “un vizio grave non contemplato dalla legge tra quelli deducibili negli ordinari giudizi di impugnazione”, tratti che in effetti rimarranno distintivi dell’atto abnorme nelle sue formulazioni successive fino ai nostri giorni. Matteotti, sempre fedele ad un principio di stretta legalità, non concorda con le posizioni che vogliono vedere sanzionati tali vizi, sostenendo un'interpretazione rigorosa della tassatività delle impugnazioni.
Un altro spunto interessante - affrontato incidentalmente in questo contributo - riguarda il ricorso in cassazione. Si tratta di un argomento caro a Matteotti, che in quegli anni stava lavorando su una monografia sul tema, avendo fatto confluire le sue prime considerazioni in questo e in altri due contributi pubblicati su rivista (Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie; Il concetto di sentenza penale e le dichiarazione d’incompetenza in particolare).
In questa sede, egli solleva un’osservazione acuta: se si accogliesse l’idea che le nullità assolute possano essere rilevate anche in sede di esecuzione, il ricorso per cassazione ne risulterebbe parzialmente svuotato di significato, venendo meno la necessità di impugnare tempestivamente la sentenza. Matteotti sottolinea che, in tale scenario, l’imputato non avrebbe più interesse a proporre un ricorso per annullamento, per costi, complessità e per il rischio di una pronuncia comunque non favorevole in sede di rinvio. Ne deriverebbe un depotenziamento dell’istituto della cassazione, che perderebbe la sua funzione di giudizio definitivo di puro diritto.
Al di là del contenuto strettamente tecnico di grande spessore, pare interessante concentrare infine l’analisi sulla estrema attenzione di Matteotti al rispetto della “procedura penale che ci regge”. Il suo obiettivo principale è quello di “arrestare le deviazioni e gli errori che in questo momento già minacciano di diffondersi”, come enuncia nella primissima parte del contributo, perchè “la chiara volontà del legislatore non è bastata a impedire le deviazioni e le interpretazioni arbitrarie”.
In questo senso, dunque, possiamo affermare che il principio di legalità processuale è protagonista assoluto del contributo, distinguendosi come tema più importante e che caratterizza sopra ogni altro l’intera produzione del Matteotti processualpenalista.
Le sezioni più illuminanti del saggio si legano infatti a questa tematica, in particolare nella parte in cui il giurista polesano afferma che ogni tradimento del senso letterale di una disposizione “è sempre una breccia che si apre in un sistema legislativo ben definito, scuotendone le fondamenta”. Particolarmente efficace è il monito: “pericolosa è la breccia anche per la difficoltà di un limite”.
Ecco, allora, che risalta tutta la incisività di questo contributo: a partire da un tema estremamente specifico e tra i più tecnici della procedura penale com’è quello delle nullità, emerge con forza la irrinunciabilità dei princìpi e dei valori espressi. Le sacre forme processuali vengono esaltate come garanzie imprescindibili, che non si possono piegare dinanzi ad altri interessi o scopi, considerati di volta in volta preminenti. Anche un fine apparentemente nobile come la ricerca della verità e della giustizia sostanziale, se perseguito oltre le regole e al di là delle procedure, finirebbe per tradursi in una forma di ingiustizia. Questo è e rimane il più importante insegnamento di Matteotti in materia di procedura penale; un insegnamento di importanza capitale, che merita di essere ricordato, compreso e valorizzato, anche per i suoi straordinari riflessi attuali.
Influenza nelle opere successive e conclusione
Sebbene si tratti del più lucido e interessante contributo di Matteotti in tema di procedura penale, purtroppo non è stato particolarmente valorizzato dalla dottrina successiva, nemmeno nelle monografie dedicate a nullità e inesistenza.
Dopo un breve rendiconto, meramente riassuntivo dell’opera, pubblicato nel 1918 [in Rivista Penale, Volume LXXXVII, 1918, p. 591, n. 141], infatti, il saggio non viene più menzionato fino a una citazione in un volume degli anni ‘50 [G. Conso, Questioni nuove di procedura penale, Giuffrè, 1959, p. 137].
Dopo quasi cento anni dalla pubblicazione, dottrina più recente ha poi recuperato quest’opera, interrogandosi anche sul motivo della scarsa considerazione ottenuta fino a quel momento: “In verità il primo fondamentale e misconosciuto contributo della dottrina processualpenalistica espressamente dedicato alla tematica dell’inesistenza fu scritto già sotto la vigenza del codice del 1913 [...]. Questo primo studio sull’inesistenza della sentenza penale è rimasto nel più totale oblio. La dottrina che ha cominciato a occuparsi del tema dopo l’approvazione del codice Rocco, dunque sei anni dopo l’assassinio di Matteotti, ha adottato (per timore? per compiacenza?) una congiura del silenzio che ha finito per contagiare anche l’ormai inconsapevole dottrina successiva alla caduta del regime. [...] Nemmeno Leone, nel suo studio così ricco di citazioni persino di autori seicenteschi; nemmeno Florian, il direttore della rivista che ospitò l’articolo – ne fa alcun cenno [...]. In questo seppur limitato ambito alla soppressione fisica dell’uomo ha fatto tristemente seguito la soppressione del pensiero.” [A. Capone, L’invalidità nel processo penale, CEDAM, 2012, p. 146].
Le altre opere
Le altre schede
La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici - Riforme penitenziarie in Inghilterra - Il segreto delle confessioni in alcune legislazioni straniere - Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen. - Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare - Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale) - Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) - Classificazione degli incidenti di esecuzione - Rendiconti analitici - G. Sabatini: Principi di scienza del diritto penale. Catanzaro 1918, pag. 205 - Il pubblico ministero è parte